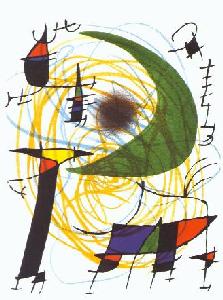 |
Associazione Medica per
lo Studio dell'Agopuntura L' ORECCHIO |
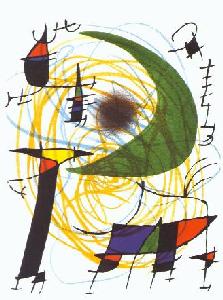 |
Associazione Medica per
lo Studio dell'Agopuntura L' ORECCHIO |
Riassunto: Si esaminano sordità ed otalgie alla luce della MTC, relativamente all’inquadramento nosografico ed al trattamennto agopunturistico, fitoterapico e dietologico. Una breve nota sul massaggio in età pediatrica è fornita nel paragrafo sulle otalgie.
Parole chiave: sordità, ipoacusia, otalgia, dolore auricolare.
"Fino a ieri eri perso nella distrazione ed anche se ti era manifesta tutta questa parte del Bardo, non l’avevi ascoltata e riconosciuta".
Bar-do Thos-grol, trad. di Namkhai Norbu, 1979-80.
SORDITA' |
IPOACUSIA |
La sordità può essere dovuta a ridotta percezione del suono nell'orecchio esterno e medio (di trasmissione) oppure a lesioni dell'orecchio interno (sensoriale) o delle vie nervose che partono dalla coclea (nervosa).L'orecchio umano percepisce suoni fra i 20 ed i 2.000 cicicli al secondo e la massima sensibilità si situa fra i 1.000 ed i 4.0000 Hz. La tonalità della voce usuale è di 120 Hz nell'uomo e 250 Hz nella donna. Normalmente la conversazione normale si sviluppa a 60 dB e a 120 db si avverte fastidio o dolore auricolare. I toni sotto i 500 Hz si dicono bassi e sopra i 4.000 alti. La massima discrimazione di tonalità è fra i 1.000 ed i 3.000 Hz. Il numero di toni discriminabili è, in media, di 2.000. Il nervo acustico termina sul bulbo e da qui partono vie, in parte dirette ed in parte crociate, fino alla regione temporale (corteccia acustica primaria, 41° area di Brodman)Queste vie attraversano i corpi quadrigemini inferiori ed il corpo genicolato mediale del metatalamo.
* SORDITA' DI TRASMISSIONE: Corpi estranei, ispessimenti della membrana del timpano,iriggidimento del piede della staffa sulle finestra ovale (otosclerosi).
* SORDITA' NERVOSA: Insufficienza vascolare del midollo allungato, malattie demielinizzanti, tumori dell'angolo ponto-cerebellare o della corteccia acustica, traumi cranici, ototossicosi da aminoglicosidici, tiazidici, salicilati, clorochina, forme dismetaboliche, disendocrine, infezioni encefaliche, malattie autoimmuni.
* FORME NEUROSENSORIALI: Traumi cranici e-o acustici, presbioacusia, forme familiari.
* FORME MISTE: Presbioacusia ed otosclerosi, ecc.
Esaminare, in tutti i casi, l'orecchio esterno e medio, eseguire tests con diapason, eseguire prove audiometriche. In alcuni casi: RMN, TAC, Arteriografia.
TEST CON DIAPASON
* WEBER: Base del diapason in vibrazione viene appoggiata sulla sommità della testa. Nel normale il suono è percepito in egual misura dalla due orecchie. Nella Sordità di Percezione più intenso (per mancanza di Mascheramento) sull'orecchio malato. Il contrario nella Sordità Neurogena.
* RINNE: Base del diapason vibrante sull'apofisi mastoide. Il diapason è sollevato in aria in vicinanza dell'orecchio non appena il paziente cessa di udirlo. Il paziente normale ode le vibrazioni del diapason sospeso. Nelle forme di trasmissione non ode il diapason sospeso; in quelle nervose ode le vibrazioni 8trasmissione aerea) del diapason.
* SCHWABACH: Confronto della conduzione ossea del paziente con un soggetto normale. Nelle forme di Trasmissione (assenza di mascheramento) la conduzione ossea è migliore. Nelle forme Nervose è peggiore (o inferiore al normale).
AUDIOMETRIA
Esistono vari audiometri che permettono di determinare la soglia di intensità minima per ciascuna frequenza mediante appositi auricolari. Si ottiene, poi, una curva che indica il grado di sordità alle diverse frequenze.
Altro esame di facile esecuzione e costo molto basso è L'IMPEDENZIOMETRIA. Si valuta la timpanometria (deformabilità e compliance timpanica, più pressione orecchio medio, più pervietà della tromba d'Eustachio) e il riflesso cocleo-stapediale (che riguarda l'integrità della catena degli osiccini e dell'arco riflesso ad integrazione centrale che comprende anche il facciale).
I POTENZIALI UDITIVI EVOCATI TRONCO-ENCEFALICI (AUDITORY BRAINSYSTEM RESPONSE o ABR) servono pert discriminare turbe coclerari e retrococleari (neurinomi dell'acustico) e si usano in caso di pazienti con basso grado di collaborazione. A questo test possono associarsene altri in caso di studio del funzionamente delle vie acustiche centrali: RISPOSTE UDITIVE A LATENZA MEDIA (MIDDLELATENCY RESPONSES o MLR) o le RISPOTE AUDITIVE CORTICALI (SLOW VERTEX RESPONSES o SVR, sopratutto del tipo P 300).
NB: Si ritiene che nei paesi industrializzati l'incidenza di sordità sia molto alta nella popolazione generale. Negli USA il 25% della popolazine al di sopra dei 65 anni è handicappata a causa di problemi auditivi er tale percentuale tocca il 30% a 70 anni ed il 50% a 75. Inoltre, secondo studon della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, la "impossibilità o difficoltà di comunicare con gli altri porta il soggetto anziano ad un isolamento personale, con conseguente comparsa di depressione, insicurezza e sospettosità".
Nell'età pediatrica l'imposibilità di udire suoni e parole (per sordità pre, peri, post-natale) conduce a quella grave menomazione sociale e psicologica che si indica come: SORDOMUTISMO. La diagnosi va posta molto precocemente (primi 8-10 mesi di vita) al fine di elaborare strategie ortofoniche e logopediche efficaci (protesizzazione acustica entro il primo anno di vita, sonorizzazione, demutizzazione, ecc.). Importante è l'esclusione di concomitanti turbe del SNC (ritardo mentale, turbe comportamentali, ecc.).
BIBLIOGRAFIA:
ER BI; ER LONG
Vi è grande confusione nei testi sia cinesi che europei circa le cause di sordità. I testi cinesi moderni affermano: la riduzione dell'acuità acustica si deve sia a cause congenite (cioè del Cielo Anteriore) che acquisite. Queste si dividono in forme "da pieno" (attacco esterno di perversi) che da "vuoto" (con coinvolgimento primario o secondario del Rene). Le prime sono forme acute ed improvvise, le seconde lente, progressive e più difficili da trattare (Ou Ming, Li Fei.). Leung sottolinea che spesso er ming e er bi sono presi come sinonimi, ma in realtà non tutti gli acufeni si associano o determinano sordità. Citando il testo I Sio Jou Menn G. Soulié De Morant scrive: "Le sordità bilaterali si debbono ad un eccesso di sapori che perturbano lo stomaco. Le sordità a sinistra sono legate a collera e malcontento che alterano il fuoco della vescica biliare. Le sordità di destra si deve a perturbazione del fuoco cosciente alterato da eccessi di desiderio e di licenza. Le prime sono più comuni delle seconde.
Inoltre le sordità si dividono in recenti o vecchie, da vuoto o da calore; le recenti mostrano eccesso di calore e le cause vanno cercate, sopratutto, a livello dello Shaoyang (VB-TR) e dello Yang-Ming (E-GI). In questi casi occorre abbassare il calore e dissipare i catarri che determinano ostruzione. Invece le forme croniche si legano ad un vuoto di Rene. In questi casi occorre tonificare. In effetti i polsi sono differenti nei diversi casi:
superficiale e mobile nei casi di fuoco (dello Shen o della VB), rapido e pieno in caso di calore; lento e molle nelle forme da vuoto". Inoltre il Ling-Shu (cap. 10) afferma che: "nelle sordità improvvise con angina bisogna trattare i punti di Shou Shao Yang". Lo stesso testo (cap. 26) ricorda che "le sordità con dolore vanno trattate sullu Shou Shao Yang". Il So-Wen (cap. 45) ricorda che, segno tipico delle turbe di Zu Shao Yang, sono le sordità con dolori alle orecchie. Infine il Da Cheng afferma: "per le diverse sordità vanno punti i punti del meridiano Shou Yang Ming: 4GI con 7 moxe (?) in caso di grande calore; 6GI in caso di sordità bilaterale; 1GI da solo o associato a 9MC". Lo stesso testo indica anche: 1Rn e 25 Rn per udito ridotto e sordità renale; 36E per sordità con intenso calore.
Volendo operare una sintesi (B. Cygler) diremo:
* Forme Liu Yin: punti di Shao-yang
* Forme calore con turbe alimentari: punti yang-ming
* Forme croniche: Rene
* Turbe psichice: LR-VB, C, MC.
Ma i punti sono davvero troppi e non selezionabili (possibile però un trattamento di meridiano).
Più interessante la classificazione seguente:
* FORME ESTERNE: Qualsiasi causa cosmopatogena (xie) può causare attacco dello shaoyang con ipoacusia e, sovente, ronzii auricolari. Vanno trattati in dispersione i punti: 17TR (yifeng), 2VB (tinghui),19IG (tinggong), 21TR (ermeng) e punto extra houtinggong (EM16) sulla radice dell'auricola in prossimità del 19IG.
Per la Farmacoterapia impiegare rimedi diaforetici e formule che scacciano il vento-calore: Ma Huang e Gui Zi Tang; se il vento-freddo si è trasformato in calore Chai Ge Jie Ji Tang, se vi è molta umidità (es. tappi di cerume): Xiao Long Dan Tang. Se vi è molto calore dare Bai Du San. In caso di catarro il punto 2MC è molto utile (assieme ai punti 12VC e 40E), assieme al decotto Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang.
In caso di "calore allo yang-ming" usare (oltre ai punti locali):
4GI, 6GI, 36E (1GI-9MC). In questi casi può usarsi la formula Bao He Wan con Huang Qin e Huang Lian (Scutellaria e Coptidis) se segni gastroenterici acuti (pirosi, alitosi, eruttazione, rigurgiti), ovvero (se invasione di LR-VB) la formula Long Dan Xie Gan Tang a base di Gentiana Scabra, Scutellaria, Gardenia, Akebia, Plantago, Alisma, Amgelica, Rehmannia, Blupeurum e Liquirizia. In caso di "calore ed umidità" dare Huanglian, zizhi, Mutong (Akebia, che comunque è un poco tossica e va usta con prudenza). In caso di dolore intenso impiegare Chuanxiong (Ligusticum walliichii) che seda elettivamente di dolori di Shao-Yang. Una formulazione molto impiegata presso il China Medica College di Taipei è la seguente: Scutellaria g 3, Angelica Dangui g 3, Cnidium g3, Peonia alba g 3, Anemarrhena g 3, Phellodendron g 3, Blupeurum g 3, Angelica dauhrica g 3, Cyperus g 3, Rehmannia fresca g 3.
FITOTERAPIA CON PRINCIPI OCCIDENTALI: In caso di forme acute: Verbana odorosa o officinalis. Se segni di calore aggiungere Biancospino e Rosmarinus off. Se anche catarro: Melissa off. Se vi è molto dolore: Spiroea ulmaria, Betula Alba, Salix Alba.
* FORME INTERNE (CRONICHE E DA VUOTO): sono legate a disfunzioni del Rene (Shen).
A) VUOTO DI JING DI RENE: Forme precoci. Insorgenza lenta e progressiva. Turbe dei denti e dei capelli. Ossa fragili (alisteresi), stordimento, vertigini, invecchiamento precoce (anche Alzheimer). Acufeni, sordità, vertigini. Dimagrimento, anemia, oligo-amenorrea. Non segni di freddo o di calore. Si deve a situazioni congenite o malattie croniche, eccessi sessuali, mestruazioni troppo abbondanti, numerose gravidanze. Il polso è profondo e vuoto. Importante controllare alimentazione e igiene di vita. Importanti il Qi Gong e le Posture. Secondaria importanza Fitoterapia ed Agopuntura.
PUNTI: 11V, 39VB, 17VG.
FITOTERAPIA OCCIDENTALE: Equiseto, Eugenia, Solidago virga aurea.
FARMACOTERAPIA: Formule per la Tonificazione dello Yin (Yiguan Jian, Liu Wei Di Huang Wan, Zuo Gui Yin) con aggiunta di piante che tonificano il jing (Eucommia, Polygonum, Astragalus complanatus, Fructus Lycii, ecc.). Oppure la formula detta "Lucchetto d'Oro per trattenere il Jing" (Jinsuo Guijing Wan) con varianti. Nelle situazioni di invecchiamento precoce impiegare formulazioni e principi "per la longevità": Ganaderma lucidum seu jiaponicum, Fungo bianco, polline e tè verde. Pietra di Maifan cinese. Combinazione di Ling zi più radix Astragali seu Hedysari, rhizoma Polygonali odorata, semen Cuscutae, herba Cistanchis, fructus Psoraleae, Margarita e Gallus domesticus. Inoltre anche il Rabarbaro Cinese (radix et rhizoma Rhei) il polline e la pianta herba Wahlenbergiae hanno questa azione.
DIETETICA: Alimenti freschi ed acidi che giovano al jing: frutta e verdura fresca e di stagione; alimenti integrali, succo di grano in erba, uova, castagna, corna di cervo, ecc.
B) VUOTO DI YIN DI RENE (E FEGATO) con liberazione di yang. Vi sono segni di calore vuoto (febbre e sudurazione serotina, pomelli arrossati, lingua rocca e secca, polso rapido e vuoto). Vi è inoltre oliguria, urine cariche e stipsi. Lombalgia, debolezza delle ginocchia, ecc. In caso di vuoto di Yin di Rene e Cuore: incubi, insonnia, palpitazioni, psicoastenia. In caso di calore-vuoto che turba il sangue: metrorraggie e spermatoree.
PUNTI: 3Rn, 3F, 23V, 7Rn, 11GI, 6Rt. 1Rn-23VC (turba Cuore-Rene).
2Rn, 66V, 2IG, 8C (turba con forte sviluppo di calore).
FITOTERAPIA OCCIDENTALE: Eugenia cariophyllata. Se coinvolgimento cuore aggiungere Crataegus oxyacantha. Se coinvolgimento sangue Angelica Archangelica.
FARMACOTERAPIA: La formulazione più specifica è la Er Zuo Qi Tang, che deriva da Liu Wei Di Huang Wan (tonica dello yin di fegato e rene) con aggiunta di Wu Wei Zi e Ci Shi (specifico dell'orecchio con azione sedativa). In caso di vuoto di Yin di Rene e Cuore Tian Wan Bu Xin Dan Wan (anche in estratto secco concentrato).
DIETETICA: Frutta, verdura, alimenti salati e marini (anche ostriche. Carne di maiale. Evitare i cibi caldi. Dare carni rosse cotte come bolliti.
C) VUOTO DI YANG DI RENE: Evento raro e spesso commisto a vuoto di yin. Da sospettare se vi è freddolosità, lombalgia, urine chiare, nicturia, mitto senza forza, polso debole e lento, lingua con impronte ed umida.
PUNTI (meglio moxe): 4-6VC, 4VG, 3-7Rn, 23V. Curiosi Chong e Ren.
FITOTERAPIA OCCIDENTALE: Solidago, Achillea, Sambucus niger.
FARMACOTERAPIA: Nelle forme miste di tipo Yin-Yang si usa la formula Jin Gui Shen Qi Wan. Nei casi con forte vuoto di yang daremo You Gui Tang sostituendo (come nell'estratto Lao Dan) Fuzi con Morinda off. Nelle forme senili severe aggiungeremo (secondo Li Fei): Shou Di Huang, Dioscorea opp., Bugu zhi, Yangyin Huo, Dang shen. In caso di diarrea toglieremo Dang shen e daremo Wu wei zi.
Nei casi con interessamento del Ren e Chong Mai (vampate di calore, parestesie e freddo alle estemità, menometrorragie, polifibromatosi uterina, ecc.) daremo la formula Gu Chong Tang (Decotto per consolidare il Chong-Mai) con aggiunta (per lo yang di rene) di Renshen (g 10) e Fuzi (g 3). Al posto di Fuzi si possono usare Rougui o Ba Ji Tian (non tossici).
DIETICA: Cibi caldi o serviti caldi. Arrosti e grigliate. Corna di cervo, grano, porro, pollo, tuorlo d'uovo, pecora, castagna, noce, uva, carpa.
D) VUOTO DI ENERGIA E SANGUE (XU QI XUE): Condizione rara. Spossatezza, dimagrimento, sudori spontanei al minimo sforzo, pallore, anoressia, insonnia, testa confusa, colorito pallido e spento o livido, palpitazioni, polso debole e sottile o ampio e vuoto, lingua pallida, molle, con induido sottile. Le malattie croniche in soggetti con complessione debole sono la causa più frequente.
PUNTI: 4GI, 36E, 43V, 6Rt, 67V, 25E, 20VB, 20VG (spesso in forte tonificazione più moxa).
FITOTERAPIA OCCIDENTALE: Erytrhaea, Fucus, Angelica, Ocinum basilicum, Urtica, Cinnamomum zeilanicum, Stellaria media, Teucryum Chamaedrys. Un buona preparazione (enolito) è la seguente: radix Angelicae, chicchi di Cacao, scorza di Cannella, scorza di Chincona, scorsa di Arancio amaro, noce di Kola, tutti g 10. Far macerare in un litro di vino bianco a basso tenore alcolico per 48 ore, poi filtrare. La posologia è di due tre bicchieri da vino al dì. In caso di depressione fisica e mentale somminisdtrare, in opercoli, la seguente formulazione: Ginseng radice 20%, Eleuterococcho radice 20%, Crisantello sommità 9%, Spirulina 10%, Fieno greco semi 10%, Pappa Reale micronizzata 20%, Pollline 10%, Rosmarino OE, Cannella OE, Salvia OE all'1%. Si danno due opercoli al mattino e due nel primo pomeriggio (di sera si può generare insonnia).
FARMACOTERAPIA: Ba Zhen Tang (in estratto).
DIETICA: Cibi dolci e piccanti. Carne di cavallo, cereali integrali, pesce, carni rosse. Fare molti pasti e ben divisi con alimenti molto digeribili (funzione del TR-Medio). Saranno molto utili il latte (e lo yougurt) ed il miele. Sun Si Miao della Dinastia Tang (vissuto fino a 102 anni) nel "Supplemento alle prescrizioni essenziali per un secolo d'oro" afferma che "il ltte è neutro e nutre sangue e vasi, tonifica il cuore, favorisce la crescita ed è consiglibile berne tutti i giorni". Le alte qualità di questo alimento sono descritte nelle cronache mediche delle dinastie Song, Yuan, Ming e Qing. Nel 1980 un fisiologo russo, dopo un viaggio di studio in Bulgaria, annotò che i molti ultracentenari ivi presenti si nutrivano di yougurt e ritenne che una sostanza prodotta dall'E.coli fosse in grado di prolungare la vita.
Utilissimo tonico è anche il miele, già magnificato nello Shen Nong Ben Cao scritto nel periodo degli Han orientali (500 anni prima di Cristo). Esso nutre il corpo ed il cervello, tonifica e combatte l'invecchiamento. Anche la medicina Ayuverdica attribuisce a questo alimento virtù tonificante, rinvigorenti ed antivecchiaia.
NB: TURBE PSICHICHE: da quanto ribadido da S.D.M. e Cygler occorre trattare o il livello Shaoyang (collerosità, inquetudine, ecc.); ovvero lo Shen (C, MC, IG, ecc.) nelle condotte dissolute.
I punti di Shaoyang attivi sull'orecchio sono ben 36 e vanno selezionati caso per caso. I punti attivi sullo Shen possono (genericamente) essere: 7C, 15V, 14VC.
Nel campo della Fitoterapia occidentale sono utuli: Rosmarinus off., Melissa off., Crataegus oxyacantha. Nel campo della Farmacoterapia cinese utili le formulazioni: Suan Zao Ren Tang (in caso di iperattività del fuoco del fegato); Zhu Sha An Shen Tang (in caso di delirio del mentale con vuoto di yin). In tutti i casi dare sedativi pesanti e sopratutto Ci Shi (magnetitum).
BIBLIOGRAFIA
| OTALGIA (DOLORE AURICOLARE) |
Le cause sono svariate, sia di tipo otologico che non otologico. Una leggera infiammazione del condotto auditivo esterno produce forte dolore. La pericondrite del padiglione (nodulo doloroso dell'orecchio) determina otalgia violenta e deformazione del padiglione. Con l'ostruzione della tromba d'Eustachio le brusche variazioni di pressione dell'orecchio medio rispetto alla pressione atmosferica possono comportare retrazione dolorosa della membrana timpanica. La causa più frequente di otalgia nei bambini è l'otite media acuta che deve essere rapidamente diagnostica e trattata, pena gravi conseguenze (perforazione timpanica, ipoacusia da cicatrice timpanica). In assenza di patologie dell'orecchio le cause di otalgia vanno ricercate in quelle aree che ricevono fibre sensitive dai nervi cranici (trigemino, glosso-faringeo, vago) che trasmettono la sensibilità all'orecchio esterno e medio. In particolare la causa di otalgia va ricercata nel naso, nei seni paranasali, nell'epifaringe, nei denti, nelle gengive, nelle articolazione temporomandibolari, nella mndibola, nella lingua, nel faringe, nell'ipofaringe, nella laringe, trachea ed esofago. Infiammazioni o neoplasie anche occulte in queste zone possono essere causa di otalgia.
BIBLIOGRAFIA
ER TONG - ER XIN TONG
Le cause essenziali sono tre: Fuoco del Cuore, Liberazione dello Yang del Rene, Freddo-Umidito che attaca lo Yin Renale.
A)ECCESSO DI FUOCO DI CUORE (Xin Huo Shang Kan; Xin Yang Pian Kiang): Compaiono: agitazione, insonnia, eritrosi a flushing diffuso del viso, calore alla punta delle orecchie, otalgia, dolore ed arrossamento degli occhi, aftosi, ulcere buccali, bocca secca, sete, eccitazione, delirio verbale, urine cariche o a lvatura di carne, disuria. Il polso è rapido e grande (sopratutto al pollice sinistro). La lingua è secca, di colore rosso vivo sopratutto alla punta.
Il trattamento consiste nel "disperdere il fuoco del Cuore" (detto anche Fuoco Imperiale o Reale).
AGOPUNTURA: MC6 (neiguan), C7 (shenmen), C3 (shaohai), TR6 (zhigou), TR17 (yfeng), TR21 (ermen) tutti in dispersione.
DIETETICA: Si darà la preferenza ai cibi amari e freddi (verdure amare ad esempio). Cointroindicati i condimenti, i cibi piccanti, i cibi grassi, gli alcolici, il fumo, il caffè, gli arrosti, ecc.
FARMACOTERAPIA: Il Neijing Sowen ricorda che "l'eccesso di calore va abbassato". Si usano piante che chiarificano il calore a livello del Cuore e del TR-Superiore con azione lassativa o diuretica. Gardenia jiasmiodes (Zhizi), Coptidis (Huanglian), Scutellaria baicalensis (Huangqinn), Phyllostachis (zhuye) (che essendo dolce combatte il dolore ed inoltre agisce anche sul Piccolo Intestino), Rehmannia radix (fresca) (Shengdihuang, Gangdihuang) (che inoltre tonifica lo yin ed il sangue). Rimedi animali sono indicati nei casi più gravi: Rhinoceros unicornis (xijiao) (che svolge un'azione antispasmodica ed antipiretica intensa; viene dato a piccole dosi: 1-2 g ed è oggi sostituito in clinica dalle corna polverizzate del Bufalo d'acqua alla dose di 10 g); Bos Taurus Domesticus seu Babulus Bubalis (niu huang) (amaro, dolce e freddo, azione antipiretica, sedativa, antispasmodica. La dose è di 0,2-0,4 g. Attualmente, in clinica, sostituito da bezoari estratti dalla colecisti o di mucche o di maiali). In caso di calore che invade il sangue si usa la Paeonia Moutan (Mudanpi), lievemente tossica (svolge una vigorosa azione antisettica su un'ampia categoria di germi). In caso di suppurazione (calore al suo massimo, calore tossico) si usano: Isatidis tinctoria (daqingye), Forsythia suspensa (lianqiao), Lonicera jiaponica (jinyinhua), Viola yedoensis (zihuadiding), Sophora subprostata (guangdougen).
FITOTERAPIA: Salix alba, Betula alba, Ribes nigrum (anche in MG 1D), Spiroea ulmaria, Amphelopsis weiictii (in MG 1D).
B) LIBERAZIONE DEL FUOCO DEL RENE (RENE YANG IN ECCESSO): Alcuni testi cinesi parlano anche di: "eccesso di fuoco del ming-men".
Compaiono inoltre: spermatorrea, ronzii auricolari, poliuria, urine chiare, stipsi, traspirazione serale e notturna, febbre vespertina, calore ai cinque centri (wu xin fan re), dolori lombari ed alle ginocchia, dolori ossei (gutong) persistenti, rarefazione ossea ecc. I polsi (mai) sono superficiali e grandi, addirittura vasti (hong) al piede di sinistra. La lingua è rossa, secca, ragadizzata, con scarso induido bianco, giallo o grigio.
Bisogna abbassare il fuoco del rene e tonificarne lo yin.
AGOPUNTURA: R1 (yongquan), R2 (rongu), IG19 (tinggong), MC6 (neiguan) TR8 (sanyangluo), TR17 (yfeng), tutti in dispersione.
DIETETICA: Alimenti salati e freddi, inoltre un poco amari. Pesci, frutta e verdura (insalata, indivia, ecc.).
FARMACOTERAPIA: Utile lo formulazione classica (anche in estratto) Liu Wei Di Huang Wan o la variante (con aggiunta di Zhimu e Huangbai) Zhi Bai Di Huang Wan (in caso di sviluppo di fuoco). Come principi attivi sul rene e che chiarificano il calore (qing re): Gangdihuang (Rehmannia glutinosa radix), Zhimu (Anemarrhena asphodeloides), Mudanpi (Paeonia moutan), Xuanshen (Scrophularia ningpoensis), Huangbo-Huanbai (Phellodendron amurense), Digupi (Lycium chinense pericarpium).
FITOTERAPIA: Arpagophytum procumbens, Ribes nigrum, Betula alba, Sambucus niger, Pinus sylvestris (anche MG 1D).
C) FREDDO ED UMIDO ATTACCANO LO YIN DEL RENE (Han Shi Shang Shen Yin): Lo yin del rene ristagna e non potendo salire non nutre le orecchie. Si hanno dolori lombari tenaci con incurvamento e deformazione ossea, ipoacusia, peggioramento climatico con esposizione al freddo ed all'umidito. Il polso è profondo e vuoto (talora lento e scivoloso). La lingua è molle, umida, atonica, con induido carico o verdastro. L'induido è più intenso al centro o alla radice. Il trattamento consiste nello scacciare freddo ed umidità e tonificare lo yang.
AGOPUNTURA: Tonificazione (con aghi e moxe) dei punti. R3 (taixi), Rn10 (yingu), MP6 (sanyinjiao), VC3 (zhongji), VC4 (guanyuan), V23 (shenshu).
DIETETICA: Si daranno cibi caldi, spezie aromatiche, cibi amari. Proibiti il latte ed i latticini, lo yogurt e le cotture a bagno maria o in umido (arrosti di carne rossa da preferirsi). Dare poca verdura e frutta. Un buon piatto è composto da ostriche (con la conciglia), guarnite con carote, patate e condite con zenzero, sale e pepe. L'aggiunta di Ligusticum wallichii (chuanxiong) allevia il dolore. Anche il "pollo ai semi di lacrima jobi" (pollo, funghi freschi, radice di zenzero tritata molto fine, succo fresco di arancio, Coix lacryma jobi, sale, pepe, vino ed acqua) è utile poichè combatte i dolori da freddo ed umidità. Nei casi di forte componente ansiosa e perdita delle funzioni cerebrali impiegato il 2salmone condito con Duzhong": salmone affumicato, Eucommia ulmoides (5 g), pepe, acqua.
FARMACOTERAPIA: Utile il preparato (in estratta) Di Huo Ji Sheng Tang a base di Angelica pubescens e Loranthus parassiticus, impiegato nei Bi cronici da "vento-freddo-umidità" con vuoto di yin. Nel caso di accumulo di flegma-umidità la formulazione di base (ma contenente la tossica Perilla ternata) è Er Chen Tang.
Fra le piante che "scaldano l'interno e disperdono il freddo" non sono da usare nè Chuan Wutou nè Fuzi (Aconitum carmichaeli radice principale o radicelle laterali) poichè cardiotossiche 8a causa dell'alto contenuto di aconitina). Si usano, invece Rougui (Cinnamomum cassia), , Ganjiang (Zingiber off.), Dingxiang (Syzygum aromaticum) (che svolge anche una potente azione analgesica locale), Huixiang (Foeniculum vulgare) (analgesico).
Una pianta molto utile (poco nota tra i cultori europei di MTC) è Wujiapi (Eleutherococcus gracilistylus), impiegato in Cina e Giappone per: disperdere vento-freddo-umidità, agire sull'insufficienza di fegato e rene, combattere i dolori delle ginocchia e della schiena, risolvere i crampi.
FITOTERAPIA: Crysanthellum americanum, Agrimonia eupatoria, Pilosella, Fagus sylvatica (in MG 1D), Zinziber off., Solidago virga aurea, Eleuterococco (in T.M. o MG 1D).
* NOTA OTALGIE IN PEDIATRIA (ER ER TONG): Come già visto sono frequenti in corso di flogosi dell'orecchio esterno e medio, ma anche per infiammazioni recidivanti delle alte vie respiratorie.
Nella pratica comune un gran numero di bambini, sopratutto in inverno, vanno incontro a riniti, sinusiti, faringotracheiti, bronchiti, otiti che, trattate con antibiotici, regrediscono senza reliquiati ma vanno incontro a recidive e ricadute. Tali bambini (linfatici e catarrali) sono spesso atopici con carenza dei sistemi naturali specifici ed aspecifici di difesa immunitaria (NK, IgA-S, lisozima, potere fagocitante e killing intraleucocitario). Inoltre l'uso di vari antibiotici spesso altera ulteriormente la situazione immune, oltre a selezionare speci microbiche resistenti e favorire contaminazioni da lieviti (candida albicans). La spiegazione energetica di tale situazione va ricercata nel fatto che l'asse Taiyin non è completamente maturo nei primi anni di vita (non matura prima dei 6-7 anni) e che il rene risulta energeticamente valido ancora più tardi. Il deficit di milza, polmone e rene condiziona da un lato una debolezza del jing, dall'altro una imperfezione della cosidetta wei-qi e questo spiega, nell'infanzia, le frequenti flogosi respiratorie invernali. Le forme recidivanti si motivano per formazione di "catarro" (tan) (non a caso in medicina occidentale si parla di "bambini catarrali"), che che ostruisce gli orifizi della testa (orecchie, naso) e blocca le alte vie respiratorie (faringe, laringe, trachea, bronchi), impedenndo la libera circolazione del qi (da cui tosse in tutti i casi per "qini": qi-controcorrente). Se il qi ristagna a lungo determina sviluppo di calore che si trasforma in pus (yong legato al re du) come nel caso di riniti, sinusiti, otiti suppurative. Il problema coinvolge il metabolismo dei liquidi (jin/ye) e più in particolare:
il Polmone (Fei) che chiarifica, purifica e fa scendere i liquidi. Se la funzione non si compie i liquidi restano nella parte alta del corpo e si trasformano in "catarro". Inoltre il resto del corpo non irrigato dai liquidi si scalda da cui febbre (re).
Il Grosso Intestino (Da Cheng) completa l'azione del Polmone (a cui è legato nel Metallo secondo Biao/Li: in effetti nel So-wen è scritto che il G.I. è implicato nella patologia dei liquidi sopratutto di tipo jin. Inoltre è noto che i punto del Polmone e del Grosso Intestino sono messi in relazione con tutta la patologia respiratoria ed O.R.L..
Milza (Pi) e Stomaco (Wei) svolgono un ruolo cardinale nella formazione dei catarri. La Milza indirizza tutta l'umidità del corpo e quando la sua funzione di trasformazione non si compie adeguatamente si formano catarri. Lo Stomaco non solo separa (primo Tri) i liquidi dai solidi il puro dall'impuro, ma rappresenta la radice interna del Polmone (il meridiano Shou Taiyin origina dal Tr-Medio) e quindi è l'alimentazione la radice di ogni terapia di affezioni respiratorie croniche o recidivanti (sopratutto in vecchi e bambini).
La Vescica Biliare (Dan) può essere implicata in forme complesse con sviluppo di "fuoco" e di pus per elevazione del cosidetto "fuoco ministro".
Il Rene (Shen) è il controllore inferiore del liquidi e del freddo-calore organico. Le sue perturbazioni sono alla base della patologia catarrale sopratutto delle orecchie e della gola.
La Vescica (Pao, Pang Chuang, Hei Chang) determina la conservazione dei liquidi, la distribuzione degli stessi al corpo (attraverso una risalita al polmone), una sorta di via finale che smista l'elaborato di tutti gli zang/fu. I dodici ministri si servono come via finale comune della vescica, che conduce alla ricchezza e prosperità di tutto il corpo. Non è un caso che Lingshu e Sowen affermino che Pao trasforma il qi e permette al qi trasformato di manifestare la sua potenza (si parl in termini cinesi di "qi hai"). Autori sia francesi (Mollard-Brusini) che cinesi (Sun Jie) hanno notato nelle affezioni croniche un deficit di enegia della vescica (questa smista anche la wei-qi formatasi a livello del Tr-inferiore, ai diversi organi attreverso gli shu dorsali).
Pertanto, sotto il profilo generale, il trattamento prevede cinque fasi essenziali:
1) disperdere il catarro e far circolre il qi ristagnante;
2) tonificare la quintessenza (jng);
3) tonificare l'energia del polmone e favorire la funzione di discesa dei liquidi);
4) tonificare il Tr-medio (Zhongjiao) per nutrire il polmone ed impedire l formazione dei catarri.
5) stimolare la formazione e distribuzione di wei-qi.
L'Agopuntura (o la stimolazione puntoscopica piezoeletrica o transcutanea eletrica nei bimbi più piccoli) si attuerà con sedute settimanali per 1-3 mesi. Meglio le moxe (in assenza di segni di calore) da fare a partire dalla piena estate (onde catturare lo yang celeste). Punti in generale: 40S, 9P, 39VB, 11V,52V, 27Rn, 12VC, 5VC, 7R.
Il Massaggio è utilissimo soprattutto fino ai 5-6 anni. Bisogna farlo ogni giorno addestrando i parenti e rivedendo il paziente ogni due settimane. Occorre sempre caldare le mani e fare il modo che chi esegue il massaggio ia calmo, tranquillo e disteso. L'ambiente in cui si esegue il massaggio deve essere a 20 gradi circa, confortevole, tranquillo e silenzioso. Si inzia con sfioramento leggero (mofa) del punto yfeng e si postano le dita verso l'estremità delle sopracciglia a scopo rilassante. Questa fase sarà molto lenta. Poi si massaggia la colonna vertebrale a partire dal sacro fino alla prima vetebra cervicale, secondo la tecnica detta "palper-rouller" (nafa). Si lavorerà anche sulla branca interna del meridiano zuTaiyang, insistendo sugli "shu" di Polmone e Milza (13-20V). Poi si eseguirà un massaggio lineare di spinta (tuifa) sui bordi dello sternocleidomastoideo dalla clavicola alla mandibola e, nei casi più gravi e nei bambini più grandi, si eseguirà anche un "pizzicamento-arrotolamento" (nafa). Questo massaggio porta la weiqi in alto e verso la faccia. Noi consigliamo di insistere sui punti 17 e 18 GI. Si esegue poi una digitopressione (polpastrello del V dito con tecnica dianxuefa) sui punti hegu (4GI), yingxiang (20GI), zhongfu (1P), yangchi (4TR) per cacciare il calore e liberare il naso, tonificare il polmone e dissolvere il catarro. Nei bambini più piccoli (4-5 anni) utile aggiungere un liee massaggio lineare (tuifa) dalla seconda barriera dei IV dito sulla mano ed avambraccio fino a daling (7MC) (area di proiezione del Polmone in micromassaggio palmare). La durata del massaggio è di tre-quattro minuti fino a 4 anni, otto-dieci in età più avanzata. In taluni casi si completa lò'azione con uno o due passaggi (dal basso all'alto) di sigaro di moxa (a tre cm dalla pelle) lungo il meridiano Ren-Mai.
- La Dietetica è molto importante. Innanzi tutto saranno consigliati alimenti ricchi in jing (alimenti freschi e non conservati o surgelati, cereali integrali, germe di grano, uova in piccole quantità, latte, miele, ecc.). Saranno utili alimenti acidi che nutrono il polmone ed astringoni i liquidi, chiarificando il calore interno: pompelmo, arancio, cocomero, pomodori, ecc.
Per tonificare il Tr-medio si consigliano alimenti debolmente dolci e diaforetici: patate, carote, riso, miglio, mais, porro, fichi, ecc.
Saranno da dare, anche, alimenti che dissipano i catarri (aromatici) come: asparagi, rabarbaro (addolcito con zucchero di canna, zucchero rosso, miele), pere, pompelmi, albicocche (che tonificano anche il polmone).
Anche alimenti piccanti e diaforetici che liberano e rinforzano il Biao (oltre ad eliminare i perversi residui): crescione, zenzero in piccole quantità, menta, mentuccia, lattuga, ecc.
saranno, invece, da proibire gli alimenti che favoriscono la produzione di catarro: grassi, dolci, zucchero bianco, gelati, caramelle, ecc.
- Farmacoterapia: In cina molto in uso la formulazione (con dosaggi adattati all'età) Banxia Huopo Tang (con Pinelliae, Magnolia, Zenzero fresco e Perillae), ricca di principi acidi che disperdono il flegma e fanno circolare il qi. Si può anche usare il "Decotto della quattro grandi erbe" (Tai Shi Tang) con semen Arecae, Ligusticum Aquilariae resinatum, radix Linderae, radix Codonopsis pilosulae, sopratutto se vi è stasi di qi di fegato e fuoco della VB. In caso di grande vuoto del TR-Medio si omette Dangshen e si aggiungono fructus Aurantii e flos Caryophilli.
Noi preferiamo o dare (a scopo preventivo) Royal-jelly (con Astragalo, Ginseng e miele) o estratto (a piccole dose e per breve periodo) di Yu Ping Feng San e se vi è molto catarro aggiungere (riducendo le dosi di Huangqi, Baizhu e Fangfeng) Xinyihua (flos Magnolia liliflora) g 2 in polvere e Gang Er Zi (Xanthium sibiricum fructus) g 2 in polvere.
* NOTA DI FARMACOTERAPIA:
In tutte le forme algiche (come semplici sedativi) dare: Chuanxiong (Ligusticum wallichii rhizoma) e Corydalis yanhusuo (Yanhusuo) rhizoma che vivifina la circolazione del sangue e sbloccano la stasi (huoxue huayuyao). Entrambi tostati ed il secondo saltato con aceto hanno più spiccata azione analgesica. Gli antidolorifici possono essere quelli stessi delle cefalee (tou tong, tou feng) in rapporto ai meridiani elettivi: Qianghuo (Notopterygii incisum) e Mangjingzi (Viticis rotundifoliae fructus) se il dolore è su Tai Yang; Baizhi (Angelica dahurica) e Gegen (Puerariae libatae radix) su yang-ming (con coinvolgimente fronte e naso), Chaihu (Blupeurum chinensis) e Huanglian (Coptidis) se Shao-yang, Wuzhuyu (fructus Schizandrae chinensis) se jue-yin.
Nel caso di iperattività del fuoco del cuore da interessamento del fegato (otalgia, occhi arrossati, turbe psichiche, dolori oculari intensi, ecc.) è molto impiegata la formulazione pronta: Mingmu Shanqi Wan (Pillole che stimolano la vista e rimuovono il calore dal Tr-superiore) con: rhizoma Coptidis, radix Platycodi, radix Scrophulariae, radix et rhizoma Rhei, fructus Autantii, fructus Gardeniae, radix Paeoniae rubra, fructus Tribuli, flos Crysanthemi, radix Scutellariae, pericarpium Citri reticulatae. Il preparato non va dato con cibi stimolanti ed è controindicato in gravidanza. Nei bambini è molto usato il preparato pronto (in supposte) Xiaoer Xiaoyan Shuan, composto da: Forsythiae fructus, Lonicerae flos, Scutellariae radix (sopratutto se dolore da flogosi auricolare o delle alte vie respiratorie).
A Taiwan si usa (nelle forme da eccesso di yang di rene) il preparato detto "Decotto a base di Crisantemo": Chrysanthemum mongolium g 1,5, Ginsemg g 1,5, Gancao g 1,5, Dangui g 3, Zhizi g 1,5, Baishao g 3, Duhuo g 1,5, Shengdihuang g 3, Shoudihuang g 3, Platycodon grandiflorum g 1.5. Invece nello forme di otite media con ipoacusia (ed anche nelle ipoacusie da otossicità) il seguente decotto: Scutellaria g 3, Rehmannia g 3, Angelica chinensis g 3, Phellodendron g 3, Cnidium g 3, Blupeurum g 3, Angelica dahurica g 3, Anemmarhena g3, Cyperus g 3. Nelle forme da "umidità e freddo" con forte ostruzione nasale (ed otalgia) la seguente formula: Xanthium fructus g 2.5, Angelica dahurica g 1, Magnolia fiori g 5, Mentha g 0.5.
BIBLIOGRAFIA