Regione Abruzzo
Azienda Unità Sanitaria Locale 04 – L’Aquila
Presidio Ospedaliero S. Salvatore
Unità Operativa Complessa di Dermatologia & Centro Allergologico
Dipartimento di Medicina
Direttore: Prof. G. Bologna

Trattamento agopunturistico somatico ed auricolare
in un
caso di ipotensione ortostatica
ed ipermobilità dei ginglimi articolari,
in un
paziente con sindrome di
Ehlers Danlos
Carlo Di Stanislao, Dante De Berardinis,
Vincenzo
D’Onofrio, Tiziana D’Onofrio
“Non c'è desiderio ardente che rimanga inappagato”
Kahlil Gibran
Riassunto: Dopo aver definito, in medicina scientifica e cinese l’ipotensione e la sindrome di Ehlers Danlos, gli AA riportano un caso relativo ad un giovane di 22 anni, che si è giovato, per la motilità articolare ed i livelli pressori, di un trattamento con agopuntura somatica ed auricolare.
Parole chiave: ipotensione, sindrome di Ehlers Danlos, agopuntura, auricoloterapia.
Abstract: After to have defined, in scientific and Chinese medicine the hypotension and the Ehlers Danlos syndrome, the AA brings back a relative case to a young person of 22 years, that it is improved, for mobility to articulate and the levels of the pressure, of a treatment with somatic and auricular acupuncture.
Key words: hypotension, Ehlers Danlos syndrome, acupuncture, auricoltherapy
Premessa
Per ipotensione si intende una condizione caratterizzata da valori della pressione sanguigna inferiori alla normalità (in generale pari o inferiore a 100 di sistolica e 60 di diastolica). L'ipotensione può manifestarsi in conseguenza di altre patologie, per esempio in presenza di uno scompenso cardiaco, di insufficienza dei surreni, di denutrizione e di disidratazione. In individui sani l'ipotensione non è sicuramente una patologia, anche se causa disturbi a volte fastidiosi, che si manifestano con senso di stanchezza persistente, giramenti di testa e apatia. Questi soggetti hanno probabilmente una sopravvivenza maggiore della media, visto che grazie alla pressione bassa non espongono il cuore e i vasi ad un sovraccarico[1]. Diverso è il discorso nel caso di ipotensione in pazienti geriatrici[2]. I meccanismi barocettivi regolano la pressione arteriosa sistemica aumentando o riducendo la frequenza cardiaca e le resistenze vascolari in risposta a riduzioni o aumenti transitori della pressione arteriosa. Con l’età, la risposta barocettiva agli stimoli ipertensivi e ipotensivi si riduce progressivamente e il rischio di ipotensione aumenta. La funzione barocettiva è molto compromessa nei pazienti anziani ipertesi. I segni della compromissione comprendono l’aumentata labilità della pressione arteriosa in risposta alle attività quotidiane e l’ipotensione in risposta a stimoli che abbassano la pressione arteriosa, soprattutto farmaci. La ridotta risposta barocettiva può essere causata in parte dalla rigidità arteriosa dovuta all’aterosclerosi, che causa una compromissione dello stiramento e del rilasciamento dei barorecettori durante le modificazioni della pressione arteriosa. La ridotta risposta adrenergica dovuta all’invecchiamento del cuore e della circolazione può diminuire la cardioaccelerazione e la vasocostrizione mediata dai baroriflessi in risposta a stimoli ipotensivi. Queste modificazioni diventano clinicamente significative quando comuni stress ipotensivi, come i cambiamenti posturali, possono non essere più controbilanciati rapidamente o completamente da aumenti compensatori della frequenza cardiaca o delle resistenze vascolari. Con l’età, il flusso ematico cerebrale diminuisce. I meccanismi di autoregolazione cerebrale, di solito, compensano le riduzioni acute della pressione arteriosa. L’autoregolazione del flusso ematico cerebrale, generalmente, si mantiene con l’età, tranne nelle persone che hanno ipotensione ortostatica sintomatica. Tuttavia, l’ipertensione cronica aumenta la soglia minima di pressione arteriosa alla quale l’autoregolazione è in grado di mantenere un flusso ematico cerebrale adeguato. Sotto questa soglia, il flusso ematico può ridursi, con conseguente aumento del rischio di ischemia cerebrale. Ipertensione, cardiopatie, diabete mellito e iperlipidemia diminuiscono ulterioriormente il flusso ematico cerebrale. A causa delle riduzioni del flusso ematico cerebrale legate all’età e alle malattie, i pazienti anziani sono più vulnerabili all’ischemia cerebrale e alla sincope, quando la pressione arteriosa si riduce. Un discorso a parte deve essere fatto nel considerare l'ipotensione ortostatica, dovuta a un funzionamento difettoso di quei meccanismi nervosi che evitano la caduta della pressione nella stazione eretta. I soggetti colpiti da questo problema hanno una pressione normale in posizione seduta o coricata, ma una marcata ipotensione quando si alzano. I sintomi, in queste persone, sono piuttosto forti, perché possono manifestarsi oscuramento della vista, perdita improvvisa ma transitoria della sensibilità e del movimento e convulsioni. L'ipotensione ortostatica può essere un sintomo di patologie neurologiche[3] (soprattutto Parkinson[*]) o altre condizioni cliniche importanti (diabete mellito e cirrosi epatica etilica), ma può anche presentarsi come unica sindrome ed essere quindi primaria o essenziale. L'ipotensione, in generale, non richiede particolari terapie se non quando i disturbi siano particolarmente fastidiosi e il calo pressorio importante. Esistono farmaci che tendono a impedire l'abbassamento eccessivo della pressione e altri che la fanno risalire a livelli di normalità. Non esiste una cura risolutiva per l'ipotensione ortostatica, ma la somministrazione di sale e di sostanze atte a combattere l'eccessiva perdita di sodio dovuta alla posizione coricata, che il paziente talvolta deve mantenere per tempi anche lunghi, danno buoni risultati in associazione alla terapia medica (con analettici, simpaticomimetici e steroidi mineralattivi[†])[4] [5]. In Medicina non Convenzionale buoni risultati sulla ipotensione si ottengono con Guaranà (ricco di caffeina) ed Eleutheroccocus, che aumenta la produzione endogena di catecolomine e corticosteroidi[6] [7]. In Medicina Cinese la causa della ipotensione è un Vuoto di Yang[8] [9] e, pertanto, una compromissione delle funzioni del Rene, del Cuore e della Milza, che, fra gli Zang, sono i “ricettacoli” dello Yang[10] [11]. La sindrome di Ehlers-Danlos è una patologia del tessuto connettivo geneticamente trasmessa, caratterizzata da alterazioni delle fibre collagene[12]. Il nome di questo particolare insieme di patologie del connettivo deriva da due medici che all’inizio del Novecento, le descrissero per la prima volta. I sintomi comuni su cui i due medici avevano appuntato la loro attenzione erano le articolazioni lasse e instabili, la pelle estensibile e delicata, la comparsa di ecchimosi per traumi molto lievi, una guarigione delle ferite lenta e con tendenza a formazione di cicatrici anomale (vedi sottostanti immagini).


Studi successivi su famiglie affette dalla malattia hanno permesso di classificarne fino a 10 diversi tipi[13] [14]. Nel 1998, però, un gruppo di esperti, clinici e genetisti, per facilitarne la conoscenza e la diagnosi ha rivisto la classificazione riducendo a 6 i sottotipi della SED. Ognuno di esso costituisce una patologia a se stante, geneticamente dovuta a un differente difetto molecolare. La prevalenza stimata è di un caso ogni 5-10 mila nati, senza che emerga una differenza per sesso o gruppo etnico[15].
|
Tipo |
Aspetti Clinici |
Ereditarietà |
Classico |
Iperestensibilità e fragilità cutanea (vedi immagini dopo la tabella) con cicatrici atrofiche, ipermobilità articolare |
Autosomico dominante |
Ipermobile |
Ipermobilità articolare generalizzata, pelle soffice e vellutata |
Autosomico dominante |
Vascolare |
pelle sottile, traslucida; fragilità e rottura di arterie, intestino, utero; facile formazione di ematomi; facies caratteristica |
Autosomico dominante |
Cifoscoliotico |
Lassità legamentosa generalizzata; scoliosi progressiva; ipotonia muscolare alla nascita; fragilità delle sclere e rottura del globo oculare (vedi foto sotto la tabella) |
Autosomico recessivo |
Artrocalasia |
grave ipermobilità articolare con sublussazioni ricorrenti; lussazione congenita delle anche |
Autosomico dominante |
Dermatosparassi |
grave fragilità cutanea; pelle pastosa e ridondante |
Autosomico recessivo |
Iperlassità tegumentaria



Forma grave di sindrome di Ehlers Danlos

Un particolare sottogruppo della sindrome è stato osservato nel 10% dei pazienti affetti da patologie dermatologiche[16]. Si tratta della varietà (di tipo III o vascolare) ipermobile benigna: ha una frequenza nella popolazione statunitense del 9% e in quella italiana del 16% e i pazienti presentano:
- spiccata ipermobilità articolare (vedi foto sottostanti)
- fragilità delle fibre collagene
- cute iperelastica e vellutata
- difetti della cicatrizzazione.






La diagnosi della sindrome ipermobile richiede la presenza dei segni
clinici e dei markers molecolari e genetici, mentre la sua gravità clinica è
valutata dai test fisiatrici e dalle indagini strumentali. La gravità clinica
della ipermobilità articolare è valutata con:
a) il
Beighton scoring system (Bss test) valuta l’ipermobilità delle articolazioni
falangee e consiste in 5 prove. Il risultato è espresso con un punteggio da 0 a 9;
b)
l’indagine ultrasonografica[17].
Il difetto genetico è ascrivibile a turbe del Jing[‡] congenito e familiare, evidenziabile, in molti casi, dalle note anomalie scheletriche ed auxologiche (vedi foto sottostanti), mentre l’interessamento connettivale (vedi foto sottostante) indica una turba della Milza[§].
Anomalie scheletriche
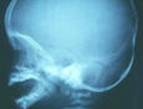


Frammentazione del connettivo in un preparato istologico polmonare
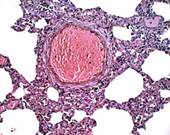
L’iperlassità e le turbe della cicatrizzazione, invece, indicano, secondo i principi della Medicina Cinese, vuoto di Yang e, di conseguenza, della Weiqi[**] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25].
Caso clinico
Alberto P., 22 anni, maschio, studente universitario. Ci consulta per un dolore persistente del ginocchio destro, secondario a trauma distorsivo da sport (calcetto). Affetto da sindrome di Ehlers Danlos di tipo cutaneo (pelle pastosa, fragile e ridontante, vedi foto sottostante) ed artrocalasico, già diagnosticata dopo indagini strumentali (RMN, visite specialistiche neurologiche, ortopediche e dermatologiche) e consulenza genetica (mappa cromosica e genetica dell’intero nucleo familiare, che ha evidenziato forma atipica di tipo recessivo). L’esame obbiettivo evidenzia iperlasità cutanea e articolare con Bss test di 7. Non aree cicatriziali. Il paziente, inoltre, soffre di frequenti crisi lipotimiche e di astenia da ipotensione ortostatica, diagnosticata dopo Holter dinamico ed indagini che hanno escluso diabete, insufficienza surrelanica o disturbi neurologici centrali e/o periferici.
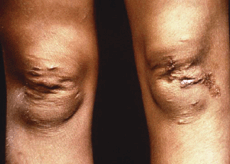
Gli proponiano un trattamento che si prefigga lo scopo non solo di sedare il dolore[††], ma di agire sulla ipotensione e la lassità legamentosa. Il paziente firma il consenso informato. I segni di interessamento di Cuore e Milza sono sfumati ma evidenti: astenia, pallore, cute pastosa, mani spesso fredde, borborigmi frequenti, cattiva digestione per amidacei. La lingua, inoltro, è pallida, gonfia, lievemente improntata, il polso lento[26]. Il volto molto pallido e la sudorazione profusa allo sforzo fisico facevano propendere per un Vuoto di Yang di Cuore[27], mentre un segno evidente, di coinvolgimento della Milza era rappresentato dalla presenza (vedi foto sottostante) di una cheilite desquamativa superficiale[28].

La presenza, nella storia del paziente, di vertigini, ronzii, difficoltà di concentrazione e basso rendimento scolastico, inoltre una netta rarefazione dei capelli e la presenza di una “glossite rombica mediana”, (vedi foto sottostante) ci confermavano la presenza di un deficit di Jing[29].

Infine, la conformazione dei denti e l’aspetto delle gengive (molto pallide) confermava un deficit di Jing e di Yang (vedi foto sottostate).
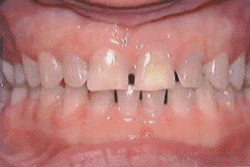
Oltre a sostenere lo Yang di Cuore e Milza, ci proponiamo di agire sul Jing mediante agopuntura somatica classica[30] [31]. Selezioniamo come punti i Beishu di Cuore (15BL) e Milza (20BL) che trattiamo con aghi e moxa ed aggiungiamo il punto GB 38 (Yangfu) (con solo ago) che, a nostro avviso [32] [33] [34], agisce sul Jing della Milza. Inoltre, con aghi a permanenza, trattiamo il punto “simpatico” auricolare, al fine di indurre incremento del tono adrenergico e giovare allla pressione arteriosa[35]. Le sedute sono settimanali, per una durata complessiva di un mese (4 accessi ambulatoriali). Si sono usati, per l’agopuntura somatica, aghi monouso Huatwo da 0,30 X 30 mm con manico in rame e moxe di pura Artemisia. Ogni seduta durava 30 minuti. Gli aghi auricolari (vedi foto sotto), sono stati tenuti a permanenza, inseriti bilateralmente e, dopo disinfezione, rinnovati una volta a settimana. Il paziente, con magnete bipolare, riattivava l’azione dell’ago auricolare mattina e sera, ogni giorno.

Nel Graf 1 sono evidenziate le variazioni di pressione arteriosa media con controlli ogni 5 giorni (T0-T6). Nel Graf. 2 il punteggio del Bss test all’inizio e alla fine della terapia.
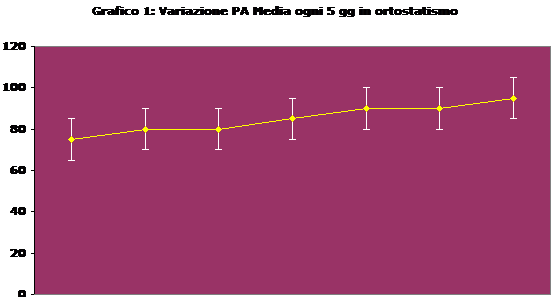
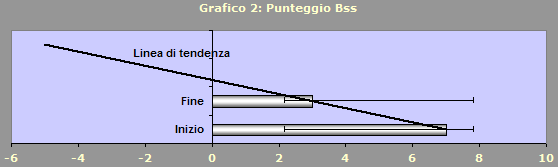
Indirizzo per chiarimenti
Carlo Di Stanislao
E-mail: [email protected]
[*] In ambito neurologico le forme di ipotensione ortostatica più frequenti sono legate ad affezioni che interessano il sistema nervoso periferico. Si hanno, però, alcune forme di ipotensione ortostatica che sebbene siano legate a malattie del sistema nervoso periferico comportano anche alterazioni a carico del sistema nervoso centrale. Il riscontro di situazioni di ipotensione ortostatica severa fa, inoltre, nascere il sospetto di non trovarsi di fronte ad un caso di morbo di Parkinson classico ma a una forma di parkinsonismo (atrofia multisistemica, sindrome di Sky-Drager). A volte, infatti, è difficile distinguere queste forme tra loro anche se da un punto di vista diagnostico ed anche clinico possiamo effettuare delle differenziazioni. Un criterio diagnostico utile per permettere tale distinzione può essere il dosaggio di sostanze prodotte dal sistema nervoso. Il valore delle catecolamine (come l’adrenalina e la noradrenalina aventi funzioni vasocostrittrici e ipertensive) può rilevarsi, nelle forme patologiche legate al sistema nervoso periferico, inferiore a quello normale. Può risultare, invece, alto oppure normale nelle patologie che presentano anche una compromissione del sistema nervoso centrale. È, peraltro, necessario che anche l’ipotensione ortostatica riscontrata nel malato neurologico sia valutata dal punto di vista cardiologico oltreché neurologico. Le ripercussioni cardiocircolatorie nel malato affetto da patologie neurologiche possono costituire un fattore di rischio cardiovascolare da non sottovalutare.
[†] Il fludrocortisone, un mineralcorticoide, sembra essere efficace nell’ipotensione ortostatica, da lieve a moderata-grave, nella maggior parte dei casi. La dose è aumentata gradualmente da 0,1 mg/die fino a 1 mg/die, finché l’ipotensione ortostatica si risolve o si sviluppano segni di edema ai piedi. Il fludrocortisone aumenta il liquido extracellulare e il volume plasmatico e sensibilizza i vasi ematici all’effetto vasocostrittore della norepinefrina.
[††] Che comunque decidiamo di trattare, dal momento che gli accertamenti strumentali (radiografia ed ecografia) ed una consulenza ortopedica escludevano lesini osteo-legamentose, sicchè prescriviamo, oltre a bendaggio elastico e riposo, agopuntura a giorni alterni (Tendino Muscolare Zu Tai Yin e unti xi del Meridiano Yang accopiatto-34ST-) e omeopatia condotta alternando, ogni 4 ore e per re giorni, Arnica e Rhus, 9 CH, 3 granuli di ciascuno ogni volta.
Per approfondimento sugli schemi vedi:
- Di Stanislao C., Gatto R.: Trattamento sintomatico del dolore in agopuntura e farmacoterapia, www.sowen.it/Milano/Materiale Didattico, 2001.
- Panzanella C.: Trattamento della gonoatrosi con agopuntura, http://www.agopuntura.org/area/tesi/gonartrosi_in_mtc.pdf, 1998.
Bianchi R.: Sport e omeopatia, Omeopatia Oggi, 2003, 23: 8-13.
-
- Di Stanislao C.: Sinossi di Clinica Omeopatica nello sport, policopie, Ed. Nobile Collegio Omeopatico-Ordine dei Medici de L’Aquila, Roma-L’aquila, 2003.
[2] AAVV: Ipotensione, http://www.msd-italia.com/altre/geriatria/sez_11/sez11_86a.html#wp9779, 2003.
[3] Bergamini L.. Manuale di Neurologia, Ed. Piccin, Padova, 1990.
[4] Negri M. (a cura di): Progressi I. Fisiopatologia e clinica. Diagnostica Farmacoterapia, con CD-ROM, Ed. UTET, Torino, 2002.
[5] Zanussi C. (a cura di): Breviario Terapeutico, Ed. Selecta Medica, Pavia, 1999.
[6] AAVV: Ipotensione, http://www.natural-space.com/ipotensione.htm, 2003.
[7] Pizzorno J.E., Murray M.T.: Trattato di Medicina Naturale, Ed. Red/Studio redazionale, Milano, 2001.
[8] Zhufan X.: Clinica pratica della medicina cinese. Il primo trattato di medicina integrativa cinese e occidentale, ed. Red/Studio redazionale, Como, 2004.
[9] Di Concetto G.: Le basi della terapia in agopuntura e medicina cinese, Ed. Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 2003.
[10] Di Stanislao C.: Turbe del Qi, del Sangue e dei Liquidi in Medicina Cinese, www.sowen.it/L’Aquila/Materiale Didattico, 2003.
[11] De Berardinis D., Di Stanislao C., Corradin M., Brotzu R.: Organi e Visceri in Medicina Cinese. La fisiologia, la clinica, la terapia, Ed. Sanli/Bimar, Roma, 1992.
[12] Ciampo E., Iurassich S.: La sindrome di Ehlers-Danlos e gli inestetismi dell’acne. Chronica Dermatologica, 1997, VII (3): 30-39.
[13] Matsen F.A. and Gardner G.C.: Ehlers Danlos syndrome, http://www.orthop.washington.edu/arthritis/types/ehlersdanlos/01, 2003.
[14] Beighton P.:The Ehlers Danlos sindrome, Ed. William Heinemann, London, 1970.
[15] Saurat J.H., Laugier P., Grosshans E., Lachapelle J.M.: Manuale di Dermatologia e Venereologia, Ed. Masson, Milano, 2000.
[16] Rossi A., Pascarella A., Pisacane D.: La pelle di Giobbe, La Pelle, 2004, 1: 20-23.
[17] Cammarota T.: Le alte frequenze nelle studio delle patologie dermatologiche, http://www.cesil.com/0598/itcamm05.htm, 2003.
[18] Reichstein G.: La danza dei cinque elementi. La medicina cinese nella vita quotidiana, Ed. Il Castello, Milano, 2003.
[19] Morandotti R.: Medicina Tradizionale Cinese, Ed. EdUP, Roma, 2002.
[20] Firebrace P.: Acupuncture. How It Work How It Cure, ED. Keats Pub. Inc., New York, 2001.
[21] Eckert A.: Manuale pratico di medicina cinese. Il potere dei cinque elementi. Qi gong, Tai Chi, agopuntura, feng shui nella cura del corpo e dell'anima, Ed. Hermes, Milano, 2001.
[22] Morandotti R.: Medicina Tradizionale Cinese. Fondamenti essenziali, Ed. EdUP, 1997.
[23] Gori G.: Argomenti di semiologia di medicina tradizionale cinese, Ed. Compositori, Bologna, 1994.
[24] Wang P., Duhamel O.: Medicina cinese. Diagnosi differenziale, Ed. Masson, Milano, 1992.
[25] Bangrazi A., Petti F.: Esperienza e progresso. L'agopuntura, la farmacologia, l'igiene nella medicina cinese, Ed. Paracelo, Roma, 1987.
[26] Auteroche B., Navailh P.: La Diagnosi in Medicina Cinese, Ed. Hermes, Milano, 1986.
[27] Ross J.: Zang Fu. He Organ System in Traditional Chinese Medicine, Ed. Churchill-Livingstone, Edimburgh, 1983.
[28] Corai A.F.: La bocca (Kou) nella tradizione medica cinese, http://www.agopuntura.org/area/tesi/bocca-kou.pdf, 1998.
[29] Manioca G.: L’esame della lingua in medicina cinese, Ed. Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1997.
[30] Konopachi D.: Punti di Agopuntura con Determinazione dei Tronchi e dei Rami ed altri appunti, CD-ROM, Ed. AMSA, Roma, 2004.
[31] Minelli E. con Schiantarelli C. e De Giacomo E.: Agopuntura clinica, Ed. Red/Studio redazionale, Milano, 2002.
[32] Di Stanislao C., D’Ammassa C.: I punti della Vescica Biliare, www.sowen.it/L’Aquila/Materiale Didattico, 2004.
[33] De Berardinis D., D’Onofrio T., Di Stanislao C. : Esperienza nel trattamento del punto guanming (GB37) in corso di mastopatia fibrocistica, La Mandorla (www.agopuntura.org), 2002, 23.
[34] Di Stanislao C.: Può l’agopuntura essere utile nel trattamento dell’aging in campo dermatologico? Considerazioni teoriche e prime esperienze, La Mandorla (www.agopuntura.org), 2002, 21.
[35] Sotte L., Muccioli M.: