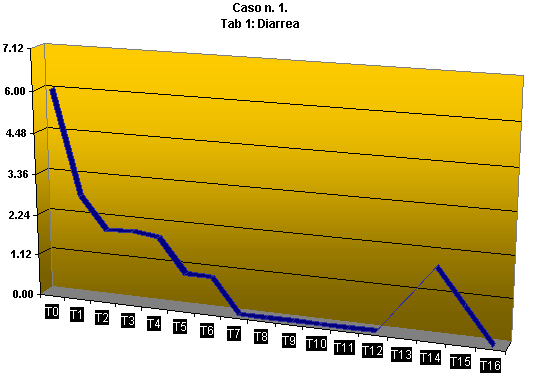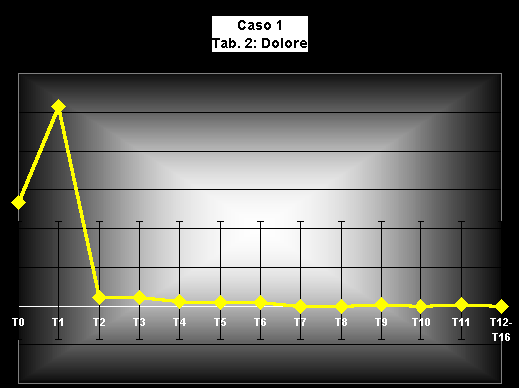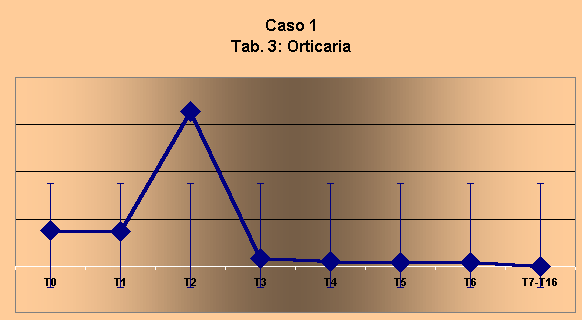A.U.S.L. 04 L’AQUILA
Divisione Dermatologica-Centro Allergologico
Primario: Dott. Giovanni Bologna
A.M.S.A.
Presidente: Dott. Carlo Di Stanislao
Attualità e
critiche alla dottrina omeopatica.
Possibile ruolo nelle reazioni avverse alimentari
in combinazione con la moxibustione |
Carlo Di Stanislao & Giovanni Bologna
"Certe volte la gente mente soltanto tacendo"
Stephen King
Riassunto: Vengono descritti pregi e difetti della dottrina omeopatica e suo
sviluppo nel mondo medico attuale. Si forniscono, infine, alcuni dati sull’impiego di
rimedi omeopatici in corso di "intolleranze" alimentari
Parole chiave: omeopatia, simillimum, intolleranze alimentari
 Fondata come
corpo dottrinario da Hahneman sul finire del XVIII secolo, l’omeopatia vuole
soddisfare il principio "similia similubus curentur", opposto a quello
ippocratico del "contraria contraris curentur" e quindi risanare in
maniera "dolce, pronta, sicura e durevole", al fine di evitare recidive ed
aggravamenti, mediante rimedi in grado di determinare gli stessi sintomi e segni della
malattia (1).
Fondata come
corpo dottrinario da Hahneman sul finire del XVIII secolo, l’omeopatia vuole
soddisfare il principio "similia similubus curentur", opposto a quello
ippocratico del "contraria contraris curentur" e quindi risanare in
maniera "dolce, pronta, sicura e durevole", al fine di evitare recidive ed
aggravamenti, mediante rimedi in grado di determinare gli stessi sintomi e segni della
malattia (1).
L’idea del simile (simillimum) non è del tutto estranea alla
storia della medicina prima di Hanemhan (2).Già nel XVII secolo il medico italiano
Fioravanti poteva scrivere "non sempre le cose sono curate dal loro contrario. Io ho
spesso visto che gli umori calidi scompaiono con rimedi caldi ed i frigidi con i frigidi e
molte qualità di infermità con i propri simili". Molti storici, poi, vedono nella
pratica della "vaiolizzazione alla Jenner" (che è coeva della promulgazione
omeopatica di Hahneman, ma si basa su un resoconto di Lady Montagu del 1721) una brillante
applicazione del "simillimum", anche se in chiave non terapeutica ma preventiva.
Ricordiamo anche che il più brillante dei "vaiolizzatori" italiani del XIX
secolo, il varesino Luigi Sacco, allievo di J.P. Frank, nel suo "Trattato di
vaccinazione con osservazioni sul giavardo e sul vajuolo pecorino", pubblicato nel
1809 (un anno prima dell’Organon), esprime idee "omeopatiche"
recepite dagli ambienti medici dell'epoca con molto diffidenza (2).
Ma il precedente più illustre e più strutturato fu quello (50 anni
prima di Hahneman) di Hunter, che partendo dall’osservazione che, talora, una
malattia scaccia l’altra, elaborò l’idea di cercare medicamenti i quali, ad una
certa posologia, fossero in grado di provocare sintomi lievissimi, in grado di scacciare o
debellare la malattia vera (1).
Anche il medico italiano Gandini (nel 1757) aveva fatto analoghe
osservazioni, ma si deve ad Hahneman lo sviluppo dottrinario della scienza omeopatica,
intesa come o m o i s r a q o s , ovvero atto di ricerca di un rimedio in grado di
sviluppare una malattia simile a quella contro cui è diretto (1,3-4).
Le critiche alla dottrina omeopatica non mancarono nei secoli scorsi e
sono ancora oggi molto tenaci e documentate (1). Spesso i ravvicinamenti fra malattia
naturale e medicamentosa sono molto forzati e l’estrema divisione dei medicamenti
costituisce un aspetto di difficile accettazione farmacologica. (1,4-6).
Circa il primo punto va notato che l’ulcera mercuriale non è per
niente simile a quella luetica (aspetto, consistenza e dolorabilità sono differenti) e
l’esantema scarlattinoso non è per nulla identico a quello prodotto dalla belladonna
(1,7-8). Lo stesso Hahneman (2,9) è molto vago sulle "esperienze esatte" nella
ricerca del simillmum e, a volte, gli organoterapici sembrano avere un mero valore
opoterapico e sostitutivo.
Ma l’aspetto più francamente criticato (7-10) rimane
l’estrema diluizione e suddivisione dei medicamenti e la loro supposta
dinamizzazione. Per ragioni pratiche Hahneman operò deconcetrazioni (diluizioni)
geometriche su base 1/10 o 1/100, intervallate da una particolare "agitazione"
definita "dinamizzazione" (d yn a m o s = energia), capace di caricare il
medicamento. Il numero delle diluizioni era compreso, di solito, fra 1 e 30 (1,3,11).
Alle diluizioni omeopatiche la dose di medicamento è in sostanza
inesistente, trovandosi al di sotto del numero d’Avogadro (6,022 x 10 alla 23°)
(1,7). Questo fatto mina nelle fondamenta ogni principio della farmacologia ed anche
volendo considerare le molecole più piccole o addirittura gli ioni in cui le molecole
possono dissociarsi, il valore limite massimo è fino alla 15° diluizione e non oltre
(7-9). Non si tratterebbe, quindi, di affermare che l’effetto non è dose-dipendente,
ma di voler credere che sia il soluto e non il principio attivo a poter risanare (9).
Comunque, nonostante gli attacchi ricevuti in duecento anni di storia (Organon
de l’arte del guarire è del 1810), la teoria omeopatica si è molto sviluppata
in Europa, Asia (India, Pakistan, Israele), Africa (Tunisia, Algeria, Marocco, Kenya,
Togo, Sud Africa, Costa d'avorio, Ghana), Nord-America (USA, Canadà, Messico),
Sud-America (Argentina, Brasile, Perù, Colombi) ed Oceania (Australia e Nuova Zelanda).
Questo perché, nonostante la difficoltà d'accetazione scientifica dei
concetti di similitudine, diluizione e dinamizzazione, i successi terapeutici, anche in
patologie refrattarie alla terapia farmacologica, sono stati molto vari e numerosi
(1,5-6,11). I vari allievi di Hahneman (Von Boenninghausen, Gressilich ed Hering negli
USA; Quinn in Inghilterra, de Guidi in Francia e Necker nel Regno delle due Sicilie) hanno
permesso una diffusione capillare delle teorie hahnemaniane e, negli ultimi 50 anni, si è
registrato un maggior ordinamento nella preparazione e distribuzione dei principi (12).
Attualmente l’omeopatia gode di larga fama fra gi utenti e di
numerosi estimatori fra medici e farmacisti. Questa fortuna è condivisa con le altre
pratiche "alternative" e spesso basata sulla sola suggestione che parole come
"olistico", "naturale", "dolce" inducono nell’opinione
pubblica (12). Ma, in primo luogo, vogliamo segnalare quanto di comune vi sia fra medicina
accademica ed omeopatica almeno nelle linee guida di relazione medicoÞ pazienteÞ
malattia. Già più di venti anni fa il prof. Ugo Teodori (13) richiamava la nostra
attenzione sui contenuti olistici, diatesici, morfosemeiologici e psicosomatici della
biomedicina, intesa nel suo sviluppo storico. Appartengono, pertanto, alla medicina in
senso lato (e non solo alle "alternative") concetti come diatesi eriditaria,
costituzione individuale, correlazioni fra abito morfologico e caratteri funzionali e
psicologici e, pertanto, non da Vannier, ma da Paracelso, Morgagni ed altri, la medicina
ha dell’uomo una visione olistica e della malattia una documentata e dinamica visione
psicosomatica (2). Affermare, pertanto, che solo le medicine "altre" individuano
interconnessioni psicosomatiche e costituzionali-acquisite, nelle diverse malattie, è un
errore metodologico che va rimosso e cancellato. Il principio secondo cui non esistono
malattie puramente somatiche o altre solo psichiche, poiché si hanno molteplici
correlazioni fra le alterazioni organiche e funzionali da un lato e la personalità
psichica dall’altro, appartiene alla medicina scientifica nei suoi dettati storici e
nei suoi risvolti attuali (2,13).
Sfruttare questo malinteso al fine di diffondere le pratiche
alternative, crediamo sia nefasto e, alla lunga, perdente. I racconti miracolisti e
l’anedottica edificante, il rimando continuo ai maestri della tradizione (Hahneman,
Kent, ecc.), l’inflazione di preparati, la letteratura di confronto, non possono
condurre a quella sana valutazione critica che, in modo sempre più evidente, è richiesta
dal mondo medico più aperto ed acculturato. Se già negli anni venti il Sabbatini (14)
richiamava alla necessità " di documentare in modo da tutti comprensibile e con
tecniche controllate e ripetibili, l’efficacia di un rimedio omeopatico", oggi
questa necessità è divenuta urgenza, di fronte ad un mercato ed ad una richiesta
crescente e con il rischio di una totale babele di voci ed un’assenza di rigorosi
controlli (7,12).
La pretesa di individualizzare l’intervento non è può essere né
un freno alla sperimentazione controllata, né un carattere distintivo, poiché, in
teoria, ogni intervento medico è individuale (1,7,13). Solo la valutazione effettiva
della qualità delle cure rese può rendere, al di là del fascino delle teorie, valide e
condivisibili alcune affermazioni (1,7).
Bisognerà, pertanto, stabilire studi controllati che saranno in grado
di spiegare alcuni interrogativi ancora oggi molto insistiti (8). Anche nel campo delle
medicine complementari il trial controllato e rondomizzato è lo strumento migliore per la
valutazione d'efficacia, ma per poterlo applicare all’omeopatia bisogna risolvere
alcune questioni di fondo (15-17):
- Definizione delle caratteristiche dei pazienti da includere.
Definizione esatta del tipo d trattamento (tipo, dose, frequenza,
durata, ecc.).
Quale tipo di gruppo controllo scegliere per il confronto.
Definizione esatta della numerosità delle coorti.
Qualificazione dei risultati.
|
Sfortunatamente nel campo dell’omeopatia e di tutte le medicine
complementari non tutti questi requisiti possono essere soddisfatti (1,15). La attenta
valutazione dei documenti internazionali e dei pronunciamenti degli esperti del settore
(15,18) ci induce a ritenere una strada possibile quella dei "casi controllo",
ovvero lo studio di casi cinici in chiave prospettica e per un sufficiente periodo di
tempo.
In questo modo sarà possibile sia una valutazione scientifica, sia una
sperimentazione aperta ed individualizzata (15).
Inoltre anche i trial patologici omeopatici (suggeriti da Fisher e
Linde) su soggetti sani al fine di registrare i sintomi prodotti, potranno, nel giro
d’alcuni anni, ad una validazione della Materia Medica tradizionale.
Le metanalisi internazionali condotte negli anni novanta da Watkins e
da Aitchison e coll., sembrano dimostrare che l'omeopatia è molto efficace, e con basso
numero di effetti collaterali, nella patologia allergia ad espressione sia respiratoria
che cutanea.
L'impiego di Galphimia assieme ad un preparato omeopatizzato di polmone
di cavia uccisa mediante provocazione di schock anafillattico (a partire dalla diluizione
7CH), riduce la gravità delle crisi e la broncoreattività alla metacolina in corso di
asma bronchiale, mentre la somministrazione orale di estratti omeopatici di miscele
polliniche era già in uso, in Inghilterra, venti anni prima dell'immunoterapia
iposensibilizzante specifica sottocute, introdotta da Noon nel 1911. Una nostra piccola
esperienza durata un anno con estratto omeopatizzato di Acari maggiori (Dermatofagoides
pteronissinus e farinae), ha dimostrato un buon indice d'efficacia nella riduzione dei
sintomi (rinorrea, ostruzione, starnuti, vellichio) in corso di rinopatia allergica (La
Lettre Dolisos, 1995).
Buoni risultati si segnalano, ma in studi non ben strutturati e
randomizzati, in corso di dermatite atopica.
Per ciò che attiene ai rimedi miasmatici sono soprattutto indicati
Sulfur e Psorinum, anche se, per i carbonici, è prescritta Calcarea carbonica.
Come rimedi più sintomatici (da impiegare in rapporto ai quadri
clinici) Arsenicum album, Sepia, Antimonium crudum, Citrus canadensis, Euphorbia lathyris,
Kali Ars., Manganum, Oleander, Petroleum, Pix liquida. Va ricordato che le Tinture Madri
di Citrus canadensis ed Euphorbia lathyris sono dotate di attività antistaminica, mentre
risultati a volte significativi sono stati descritti impiegando, come adiuvanti
alimentari, il manganese (anche omeopatizzato alla I D) commisto ad acidi grassi di tipo
omega-3 (in dosi ponderali).
Nostra esperienza nelle reazioni avverse alimentari
Si definiscono False Allergie Alimentari (FAA) l'insieme dei disturbi
intestinali ed extraintestinali, che assumano la forma di una reazione reaginica in
relazione ad un rilascio istaminico non specifico. Tali condizioni si verificano se si
manifesta una delle tre seguenti condizioni:
Consumo eccessivo di uno o un gruppo di alimenti o ricchi di istamina
o che attivano un processo istaminico (latte, latticini, banane, sardine, gamberi,
fragole, ecc.).
Alterazioni funzionali della mucosa digestiva con alterato passaggio
di macromolecole.
Alterazione dei rapporti fisiologici fra organismo ed istamina a
causa di un rilascio anomalo mastocitario e basofilico o per anomalia del suo catabolismo
(turba della istidin-decarbossilasi).
Mentra i testi immunologici in vitro (IgE ed IgG4 specifici,
degranulazione specifica mastocitaria,ecc.) ed alcuni testi in vivo (prick e
prick-by-prick) sono solitamente negativi, la provocazione orale anche in doppio cieco ed
il test leucocitossico (di Byrant) possono risultare positivi.
Un test dirimente in corso di FAA, è il protocollo che prevede
l'impiego, distanziato da un'ora ed a cieco semplice, di capsule opache di gelatina con:
Lattosio 100 mg
Tiramina 40 e poi 100 mg
Feniletilamina 3 mg
Nitrito sodico 4 e 8 mg
La provocazione orale si considera positiva quando si verifica una
riproducibilità della sintomatologia oggettiva o un'esecerbazione dei sintomi
identificati.
Il test va eseguito sotto controllo medico ed in un centro ospedaliero.
Ci siamo occupati in passato (19-20) di dignostica bioenergetica e
trattamento agopunturistico e fitoterapico di pazienti con reazione avversa alimentare non
IgE-mediata. In questi ultimi mesi, a seguito d’alcune osservazioni di Miccichè
(21-22), abbiamo iniziato una ricerca "caso controllo" (con una durata media di
otto mesi quanto a follow-up) relativa ad alcuni bambini (dai cinque ai dodici anni) con
note intestinali ed extraintestinale d’intolleranza alimentare (F AA). La diagnosi è
stata effettuata mediante prick test con prodotti sia del commercio sia freschi, test
orale a solo cieco per FAA e Sarm-Test (metodica bioenergetica) e confermata con dieta
d'esclusione per 30 giorni e reintroduzione successiva degli alimenti sospetti.
Il protocollo di trattamento ha previsto l’impiego (2\3 volte al
dì) di cromoglicato disodico idrosolubile (200- 300 mg/die) mezz’ora prima dei pasti
principali un rimedio omeopatico "neutralizzante" alla 9CH, 2-3 granuli per
volta alle ore 10-17 e 22 e moxibustione settimanale. La dieta è stata tenuta libera con
esclusione d’additivi e conservanti. Il trattamento ha avuto una durata di due mesi d
il follow up è andato dai sei ai dieci mesi.
I principi omeopatici sono selezionati in rapporto al seguente schema
(21-26).
I punti d’agopuntura sono stati trattati in moxa, con sigari di
fabbricazione cinese "Ta I" e con metodica detta "a becco d'uccello"
sino alla sensazione di "calore profondo". I punti prescelti sono stati: SI 11,
TE 7, CV 17, GV 6, CV 11-12-13 (con piccole variazioni individuali) (20).
Sebbene i nostri dati siano ancora esigui, abbiamo notato, a dieta
libera, una netta riduzione dei segni sia intestinali (vomito, diarrea, crisi coliche) che
extraintestinali (ipercinesia, cefalea dermatite, orticaria) legati l’assunzione di
cibo.
Riferiamo, a scopo esemplificativo, due differenti casi clinici.
Caso I
A. Laura, 6 anni e 9 mesi, secondogenita. Da circa 14 mesi crisi di
orticaria ricorrente con dolori addominali ed episodi (circa tre la settimana) di diarrea
acquosa.
Non atopia né familiare né personale (IgE totali 23 mU/100ml;
IL2-4-10, Rast per Alimenti principali ed Acari Maggiori, prick per trofo e
pneumoallergeni, negativi). Ha avuto uno sviluppo psicofisico ed un divezzamento normali.
Non precedenti potologici di rilievo.
L'esame microbiologico e parassitologico delle feci è risultato
normale. Normale anche il pH e la quantità di tricliceridi. Il test del sudore e l'acido
sialico ematico sono risultati nella norma.
Il Sarm Test ha evidenziato intolleranza per pomodoro, grano e carne di
manzo. Il test progressivo per FAA reazione positiva (prurito, orticaria e/o dolore
addominale) per lattosio, tiramina a 40 mg e nitrato sodico.
Una dieta priva di grano, pomodoro fresco, carne di manzo, latte di
mucca, latticini, frutta esotica, frutta secca, cioccolato e cibi conservati (si davano
latte di soia, formaggio di soia, farro, riso, granturco, mais, carni bianche, pesce) ha
determinato, dopo un mese, scomparsa delle crisi sia gastroenteriche che urticariose.
Dopo reintroduzione di dieta libera ricomparsa (fra il settimo ed il
decimo giorno) dell'orticaria e delle crisi coliche addominali.
Abbiamo eseguito un trattamento per due mesi con:
Dieta libera con esclusione solo di conservanti e/o coloranti.
Cromoglicato disodico 100 mg mezz'ora prima di pranzo e cena
Ferrum metallicum e Aethusa cynapium 9 CH, 1 granulo diciascuno ore
10 ed ore 22.
Moxabustione una volta alla settimana (totale di otto sedute) sui
punti huizong. tianzong, shangzhong, jizhong, zhongwei, impiegando sigari di tipo
"Tai I", di fabbricazione cinese (distruibiti dalla GMT 2.000 di Laveno), con
tecnica " a becco d'uccello".
Abbiamo poi interrotto il trattamento e, lasciando la sola restrizione
per gli additivi alimentari, eseguito controlli quindicinali per sei mesi.
Le Tab. 1-3 mostrano l'andamento della diarrea, dei dolori addominali e
dell'orticaria.
I tempi (T0-T16) sono espressi ad intervalli di 15 giorni.
La diarrea e il dolore addominale sono calcolati in numero di episodi.
L'orticaria, invece, come score medio con livelli a 4 punti, in base
sia alla frequenza che alla gravità delle crisi.
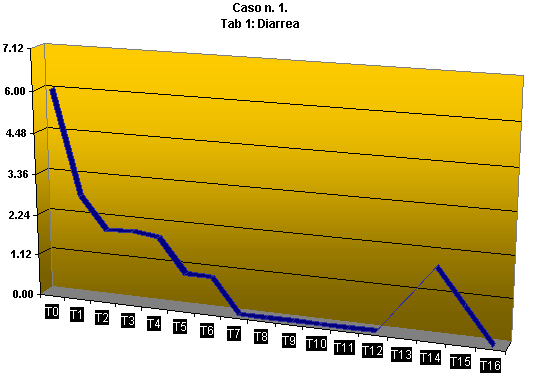
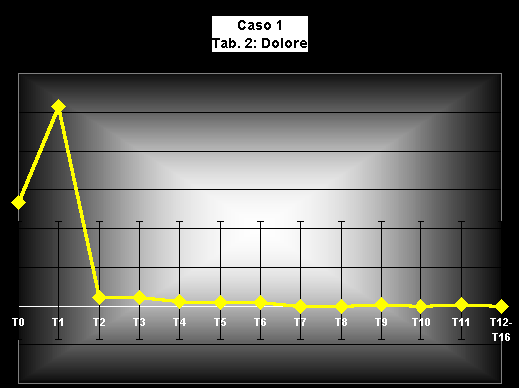
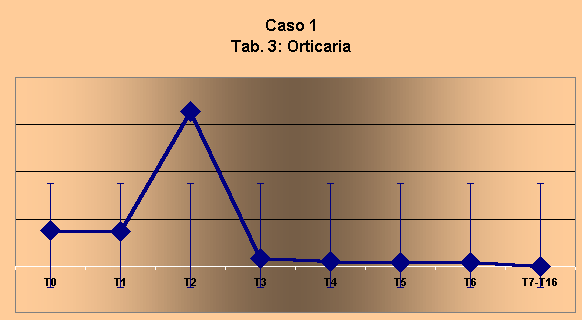
Il test orale per FAA in unico cieco, eseguito sia a fine trattamento,
sia dopo follow up è risultato negativo.
Il Vegatest è risultato negativo dopo il periodo attivo e positivo per
il pomodoro (caduta dell'indice impendenziometrico del 30% versus controllo) dopo il
follow-up.
Caso II
M. Ginetta, 12 anni e 3 mesi. Cefalea vasomotoria e prurito diffuso con
lesioni escoriate da grattamento. La forma cefalagica è insorta da 10 mesi (diagnosi di
emicrania giovanile presso il locale Centro delle Cefalee). Il prurito insiste da circa 8
mesi. L'esame dermatologico è risultato negativo. Familiarità per emicrania (madre,
nonna materna ed una zia paterna). Non familiarità allergica. IgE totali e specifiche
normali. Prick test per trofo e pneumoallergeni negativi. Scatenamento orale in doccio
cieco per latte, uova, merluzzo, grano, negativi. Discreta risposta sintomatica con
flunarizina 5 mg/die, interrotta per eccessa sedazione con riduzione del rendimento
scolastico.
Sarm Test positivo per grano. Test leucocitossico (eseguito in altra
sede) positivo per grano. Test orale in solo cieco per FAA positivo per tiramina (40 mg) e
feniletilamina.
L'esclusione di additivi e grano dalla dieta ha portato, in un mese, a
scomparsa del prurito e netta riduzione del numero e della gravità delle crisi di
cefalea.
La reintroduzione del grano nella dieta ha prodotto, in quindici
giorni, riacutizzazione del prurito e della cefalea.
Abbiamo eseguito terapia per due mesi con:
Dieta libera priva di conservanti, coloranti e cioccolato.
Cromoglicato disodico 300 mg die (100 mg prima di colazione, pranzo e
cena)
Bryonia 9 CH, 2 granuli alle ore 10 e 2 alle ore 22.
Moxibustione settimanale con le stesse modalità e sugli stessi punti
del caso precedente.
In questo caso il follow-up è stato di 10 mesi.
Le Tab. 1-2, con dati raccolti ogni 15 giorni (T0-T24), indicano
l'andamento medio delle crisi di emicrania (frequenza, durata, intensità) e del prurito
(frequenza ed intensità).


Il test orale FAA in unico cieco dopo periodo attivo è risultato
negativo per feniletilamina e dubbio per tiramina (a 100 mg). Entrambe le sostanze sono
state tollerate dopo il follow-up.
Il Vegatest per il grano è risultato negativo dopo periodo attivo e
positivo (caduta dell'indice impedenziometrico del 20% rispetto al controllo) dopo
follow-up.
Conclusione
L'eliminazione d’alimenti scatenanti è la sola terapia razionale
delle allergie e pseudoallergie alimentari. Purtuttavia vi sono ragioni di ritenere che
sia possibile, in talune forme di FAA, indurre una tolleranza di lunga durata mediante
terapie combinate convenzionali e non convenzionali. Mentre è ben noto il meccanismo
d'azione dei cromoni (ridotto assorbimento di macromolecole e stabilizzazione della
membrana mastocitaria) la moxibustione su punti dell'agopuntura cinese ed alcuni rimedi
omeopatici "neutralizzanti" potrebbero ristabilire un ottimale equilibrio fra
organismo ed istamina, normalizzando il rilascio di mediatori neuro-vasoattivi a livello
sia mastocitario che basofilico.
E' possibile ritenere, almeno a livello teorico, che la moxa sui punti
dell'agopuntura cinese, possa aver modificato alcune molecole del sistema HLA di classe
seconda, collegate con le flogosi minime intestinali e pertanto migliorato
l’assorbimento intestinale di principi proteici scatenanti.
Sebbene concettualmente non avremmo dovuto impiegare la moxa (jiao)
in malattie con espressione di tipo "calore", questa metodica è stata preferita
non solo per la minore aggressività, ma perché molto attiva (secondo il Lingshu e Sun Si
Miao) in età pediatrica.
Bibliografia
- Niccolini P.: Omeopatia, In Enciclopedia Medica Italiana, Vol 10, Ed. USES, Firenze,
1983.
- Zanobio B., Armocida G.: Storia della Medicina, Ed. Masson, Milano, 1997.
- Hahneman S.C.: Esposizione della dottrina omeopatica, Ed. Lampato, Venezia, 1834.
- Zammarano F.: Medicina Omeopatica, Ed. Cappelli, Bologna, 1951.
- Horvilleur A.: L’homéopathie et son avenir, Ed. Camugli, Lyon, 1979.
- Benjamin M.: Omeopatia – Un’alternativa alla medicina ufficiale, Ed. Bompiani,
Milano, 1973.
- Tognoni G.: Aspetti armacologici-clinici dell’omeopatia, in Enciclopedia Medica
Italiana, Vol 10, Ed. USES, Firenze, 1983.
- Gibson R.G., Gibson S.L. et al.: Pharmacological aspetcs of homeopathy, Br. J. Clin.
Pharmacol., 1980, 9:453-459.
- Goodman L.S. & Gilman A.: Le basi farmacologiche della terapia, Ed. Vallardi,
Milano, 1967.
- Hardman J.G., Limbird L.E. et al.: Goodman & Gilman Le Basi Farmacologiche della
Terapia, IX Edizione, Ed. Mc Graw-Hill, Milano, 1997.
- AAVV: Repertorio Omeopatico, Ed. IMO, Milano, 1990.
- AAVV: Documento FNOM sulle Medicine Non
Convenzionali, 30 marzo 1999,
- Teodori U.: Introduzione al Trattato di Patologia Medica, Vol I, Ed. USES, Firenze,
1974.
- Sabatini L.: Valutazione in omeopatia, Arch. Sci. Biol., 1921, 2: 161-170.
- Linde K.: Come valutare l’efficacia delle terapie complementari, Atti del Congresso
Internazionale Metodologie della ricerca Clinica in Medicina Complementare, a cura
dell’Associazione Medici Agopuntori Bolognesi, Riv. It. d’Agopunct., 1998, 91:
6-7.
- Vickers A.: Come valutare l’efficacia dell’omeopatia, Atti del Congresso
Internazionale Metodologie della ricerca Clinica in Medicina Complementare, a cura
dell’Associazione Medici Agopuntori Bolognesi, Riv. It. d’Agopunct., 1998, 91:
15.
- Keijinen J., Kinpshild P., Riet G.: Clinical trial oh homeopahy, Br. Med. J., 1991, 302:
316-323.
- Boissel J.P., Chucherat M. et al.: Critical Literature Review on the efectiveness of
homepathy. In report of Homepathic Medicine Research Group 195-210.Commision of the
Eurpean Comunities, Directarate-General XII, Brussels, 1996.
- Watkins A.D.: The role of alternative therapies in the treatment of allergic diseases,
Clin. Exp. Allergy, 1994, 24:813-824.
- Aitchison D., Carter R., Stevenson R.D.: Is evidence for homeopathy reprocucible ?,
Lancet, 1994, 344:1601-1606.
- Ullman D.: Homeopathy and Menagent Care: Manageable and Unmamageable, The Journal of
Alternative and Complementary Medicine, 1999, 5: 65-74.
- Fiorini G., Rinaldi M.: Argomenti di Allergologia, Ed. Selecta Medica,Pavia, 1999.
- AAVV: Prontuario Pascoe. Manuale di Farmacoterapia di Regolazione ed elenco dei
Medicamenti, Ed. Named, Milano, 1992.
- Di Giovanni G.: Clinica Omeopatica delle Dermatiti Allergiche, Cahiers de Biotherapie,
1997, 4: 7-12.
- Moneret-Vautrin D.A., Grillanti J.P.: Allergie alimentari, pseudollargie alimentari et
nutrition, Encyclopedie Medico-Chirurgical, Nutrition, Ed. Thecniques, Paris, 1981.
- Botey J. Sever M.T., Monreal P. et al.: Otto casi di false allergie alimentari, IV
Workshop Latino sulle Allergie Alimentari, Montecarlo, 29 novembre, 1 dicembre 1990, Atti,
Ed. Fisons, Roma, 1992.
- Diehl D.L.: Acupuncture for gastrointestinal and hepatobiliary disoders, The Journal of
Alternative and Complementary Medicine, 1999, 5: 27-46
 Fondata come
corpo dottrinario da Hahneman sul finire del XVIII secolo, l’omeopatia vuole
soddisfare il principio "similia similubus curentur", opposto a quello
ippocratico del "contraria contraris curentur" e quindi risanare in
maniera "dolce, pronta, sicura e durevole", al fine di evitare recidive ed
aggravamenti, mediante rimedi in grado di determinare gli stessi sintomi e segni della
malattia (1).
Fondata come
corpo dottrinario da Hahneman sul finire del XVIII secolo, l’omeopatia vuole
soddisfare il principio "similia similubus curentur", opposto a quello
ippocratico del "contraria contraris curentur" e quindi risanare in
maniera "dolce, pronta, sicura e durevole", al fine di evitare recidive ed
aggravamenti, mediante rimedi in grado di determinare gli stessi sintomi e segni della
malattia (1).