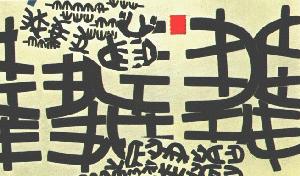 |
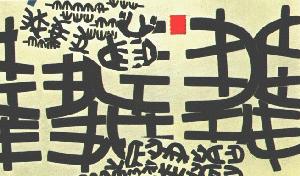 |
L’ACQUISIZIONE DEI DATI NEI VARI APPROCCI MEDICI:
ANAMNESI ED ESAME OBIETTIVO NELLA MEDICINA "CONVENZIONALE", NELLA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE (AGOPUNTURA) E IN OMEOPATIA.
Marialucia Semizzi
Riassunto: Viene presa in considerazione la raccolta dei dati diagnostici secondo la Medicina "Convenzionale", secondo la Medicina Tradizionale Cinese e secondo l’Omeopatia unicista. I tre differenti approcci vengono comparati attraverso un esempio clinico: l’influenza.
Parole chiave: Metodologia clinica, diagnosi, agopuntura, omeopatia.
Summary: The diagnostic data collection is examined according to approaches of Conventional Medicine, Traditional Chinese Medicine and Homoeopathy. Three different approaches are comparated through a clinical example: influenza.
Key words: Clinical
Methodology.
Diagnosis.
Acupuncture.
Homoeopathy.
Ringraziamento: un grazie al professor Paolo Bellavite, che ha rivisto la parte concernente l’omeopatia.
Quando parliamo dei vari approcci in medicina pensiamo all’approccio tradizionale, che impariamo all’Università, e agli approcci "alternativi" messi in atto dagli omeopati, dagli agopuntori, ecc. e pensiamo questi approcci in qualche modo in competizione tra loro o comunque non raffrontabili.
In questo articolo si vuole proporre una comparazione tra i vari metodi, dimostrando che le varie medicine non sono in realtà tra loro "alternative", bensì "complementari", ossia in grado di integrarsi l’una con l’altra formando l’unica Medicina possibile.
Qui ci si soffermererà solo sulla prima fase dell’atto medico, che è quella dell’acquisizione dei dati, e per le medicine cosiddette "non convenzionali" prenderemo in considerazione soltanto omeopatia e medicina tradizionale cinese: verrà illustrato schematicamente il procedimento attuato dalle varie medicine, evidenziando la peculiarità dei vari approcci e confrontandoli infine con quello "convenzionale", che è l’unico a tutti ben noto.
La scelta delle due medicine "non convenzionali" di cui trattare è stata condizionata dalle conoscenze personali e dalla convinzione che comunque anche le altre medicine non convenzionali siano, mutatis mutandis, riconducibili a queste, per quanto riguarda il metodo diagnostico.
¨ ¨ ¨ ¨
Schematicamente possiamo pensare l’atto medico costituito da tre fasi:
I fase: acquisizione dei dati;
II fase: elaborazione dei dati e formulazione della diagnosi;
III fase: prognosi e prescrizione del comportamento terapeutico.
Questo schema è valido per tutte le medicine, ma le modalità di acquisizione dei dati, i ragionamenti attuati per pervenire alla diagnosi, il tipo di diagnosi e conseguentemente il tipo di terapia prescritta sono differenti a seconda del sistema medico considerato.
Prima di procedere nell’analisi è indispensabile focalizzare alcuni concetti:
- tutti i tipi di medicina traggono gli elementi diagnostici dal malato attraverso l’interrogatorio, l’osservazione e l’esame del Paziente (in toto o di sue componenti: secreti, sangue, urine, feci, eccetera); differisce però a seconda della medicina considerata l’importanza attribuita alle varie tappe di acquisizione dei dati e differiscono grandemente la qualità e la quantità di informazioni che si riescono ad interpretare ed utilizzare per formulare la diagnosi e impostare la terapia.
- Parliamo di elemento peculiare di una data medicina quando l’elemento considerato non è reperibile nei manuali di clinica o di semeiotica di altre medicine. Non si può dire che non appartiene ad una medicina un elemento in teoria raccomandato, ma nella pratica sottovalutato o trascurato dai medici esercitanti quel tipo di medicina.
- Naturalmente fa parte della Medicina convenzionale anche la psichiatria (che tuttavia ha delle modalità di conduzione dell’anamnesi in parte peculiari).
MEDICINA "CONVENZIONALE" (O TRADIZIONALE OCCIDENTALE O "UFFICIALE" O "ACCADEMICA" O "ALLOPATICA")
Il termine di Medicina "allopatica" non mi piace perché riduce la medicina tradizionale occidentale alla prescrizione di sostanze, mentre essa è più vasta e complessa: prescrive sì farmaci "allopatici", ma anche sostitutivi "omologhi" come insulina e ormoni, regole igieniche, e opera interventi chirurgici. Pertanto non parleremo di medicina "allopatica", ma di medicina "convenzionale", riferendoci alla medicina esercitata in quasi tutti i paesi industrializzati del mondo.
L’acquisizione dei dati necessari a formulare la diagnosi è un iter molto complesso e modulabile a seconda della richiesta. E’ fondato su tre elementi che vanno considerati in sequenza non invertibile:
1: anamnesi
2: esame obiettivo
3: indagini di altro tipo (esami bioumorali, strumentali, bioptici).
L’ANAMNESI riveste un ruolo fondamentale e serve a raccogliere più dati possibile sulla manifestazione di malattia. I manuali di semeiotica medica e metodologia clinica sono molto ricchi al riguardo e si rimanda ad essi per i dettagli. Attraverso l’anamnesi si cerca di studiare anche il "terreno" su cui si è inserita la malattia attuale, sondando i precedenti patologici di quel malato, i tratti della personalità e il vissuto, le abitudini di vita, i precedenti patologici familiari, la presenza di particolari fattori di rischio, l’ambiente domestico e lavorativo, eccetera. Non c’è un limite all’elenco delle cose di cui informarsi nell’anamnesi: tutto ciò che può essere utile. In vista di ciò che si dirà più avanti riguardo le altre medicine, va però sottolineato che l’anamnesi tradizionale è mirata ad evidenziare gli aspetti PATOLOGICI del vissuto del paziente, mentre non si occupa minimamente (eccettuata la psichiatria) delle caratteristiche attribuibili alla naturale diversità tra gli individui (gusti personali, attrazione per certi colori, posizioni abituali in cui si dorme, fonti di piacere emotivo o di disagio, contenuto dei sogni o delle paure, ecc.). Anche il ritmo di comparsa o scomparsa dei sintomi, l’associazione con determinate ore del giorno o della notte o con particolari manifestazioni metereologiche/stagionali o con funzioni fisiologiche (cibo - sonno - mestruazioni - alvo) sono normalmente valutati in modo molto grossolano.
L’anamnesi può essere considerata l’elemento insostituibile e fondamentale dell’iter di acqui-sizione dei dati necessari per pervenire alla diagnosi: un’anamnesi ben condotta spesso è sufficiente da sola a formulare un sospetto diagnostico corretto, che viene poi confermato o smentito nelle tappe successive. La trascuratezza con cui purtroppo molti medici convenzionali conducono l’anamnesi fa a torto ritenere a molti che la medicina "ufficiale" dia poca importanza a questa fase diagnostica.
L’ESAME OBIETTIVO è altrettanto fondamentale e ricco: mira a rendersi conto delle condizioni reali del paziente, valutando l’oggettività e gravità dei sintomi lamentati e tentando di capire il grado di compromissione dello stato di salute. Anche senza l’ausilio di altre indagini un’accurata visita che utilizzi davvero tutte le conoscenze disponibili, associata ad un’anamnesi ben condotta, è in gran numero di casi sufficiente a pervenire quantomeno ad un corretto sospetto diagnostico e a impostare empiricamente una buona terapia.
L’esame obiettivo inizia già durante l’anamnesi con l’osservazione del paziente: l’aspetto generale, come è vestito (accurato, trasandato, con abiti di pesantezza adeguata al clima, ecc.), come parla, come sta seduto sulla sedia, come si muove, come gesticola. Poi prosegue, all’inizio della visita vera e propria, osservando come il paziente si spoglia, se fa fatica a compiere i gesti o no, se riesce a salire da solo sul lettino e a stare disteso. Sono a tutti i medici ben note le modalità di svolgimento dell’esame obiettivo, ma si sottolineano alcune cose, in vista del confronto che si farà più avanti.
Quando il medico valuta la "facies" del paziente, mira a riconoscervi una PATOLOGIA, mentre non è normalmente in grado di riconoscere elementi diagnostici negli atteggiamenti posturali, nelle caratteristiche della cute e dell’incarnato, nell’espressione o nel modo di esprimersi del soggetto, qualora non francamente patologici; anche la distribuzione corporea di alterazioni cutanee o la lateralità di certi segni o sintomi non vengono in genere considerati perché non utilizzabili. Purtroppo anche per quello che riguarda l’esame obiettivo va detto che di rado è espletato interamente, e questo non solo per trascuratezza o fretta, ma anche per convenzioni di altro genere: si rispetta il senso del pudore del paziente e perciò non lo si fa spogliare completamente; la dentatura è di competenza odontoiatrica e perciò si demanda il suo esame allo specialista; lo stesso vale in genere per la vista o per l’apparato urogenitale.
Per quanto riguarda le ULTERIORI INDAGINI si farà un cenno soltanto. Le possibilità che la medicina convenzionale offre per integrare e completare i dati ricavati dall’anamnesi e dall’esame obiettivo (test funzionali, laboratorio, microscopia, microbiologia, radiodiagno-stica, ultrasonografia, endoscopia, chirurgia esplorativa, anatomia patologica, eccetera) sono enormi e consentono quasi sempre di pervenire ad una diagnosi precisa a patto che la malattia abbia elementi oggettivabili. Infatti, benché in alcuni casi la negatività dell’esame obiettivo e delle indagini sia proprio l’elemento diagnostico richiesto, in genere di fronte a situazioni tutte "soggettive" (in cui l’anamnesi da sola suggerisce l’esistenza di un disturbo che poi non si riesce ad oggettivare in alcun modo né con l’esame obiettivo né con altri sistemi di indagine) si è portati a concludere - forse erroneamente - che "non vi è alcuna malattia vera e propria". Anche questa discordanza tra ciò che il malato prova e ciò che si riesce a diagnosticare e quindi a curare è alla base della ricerca di risposte nelle medicine non convenzionali.
Non è questa la sede per considerare se la reale utilità e necessità degli approfondimenti diagnostici sia sempre valutata prima di prescriverli o se piuttosto essi siano talvolta presi come una "scorciatoia" per giungere più in fretta alle conclusioni risparmiando tempo sull’anamnesi e sull’esame obiettivo. Va invece sottolineato che questa terza tappa dell’acquisizione dei dati è in buona parte peculiare della nostra medicina, non ritrovandosi nelle altre. Le possibilità diagnostiche della medicina convenzionale sono quindi infinitamente superiori a quelle di tutte le medicine non convenzionali, anche se logicamente l’avere più dati e perciò sapere di più non significa necessariamente capire di più.
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE
Nel breve spazio a disposizione è impossibile spiegare in cosa consiste la medicina tradizionale cinese, che è un sistema diagnostico-terapeutico e di prevenzione molto complesso, che richiede molti anni di applicazione e studio per essere compreso e appreso e per poter quindi essere giudicato. Dirò solo ciò che è essenziale per comprendere l’iter diagnostico, operando delle grossolane approssimazioni e scusandomi in anticipo con chi conosce approfonditamente questa materia.
La visione cinese, che è quella taoista-confuciana, è una visione dinamica. La materia è condensazione di energia e può dissolversi liberando la sua energia potenziale, dato che l’energia e la materia sono continuamente in movimento e continuamente trapassano l’una nell’altra: non vi è mai materia senza alcuna energia né energia senza alcuna materia e il grado di energia come quello di materia non sono mai stabili. Energia e materia sono inversamente proporzionali tra di loro: maggiore è l’energia e minore la materia e viceversa. La materia più pesante, meno dinamica, più fredda, più profonda, più "terrestre", a minore contenuto di energia è chiamata YIN, quella meno materiale, più dinamica, più calda, più superficiale, più "celeste", più ricca di energia è chiamata YANG. L’universo è costituito da cinque elementi, generati all’inizio dal Cielo o dalla Terra in cicli successivi: legno, fuoco, terra, metallo, acqua. Nella natura questi elementi si generano e si controllano l’un l’altro.
Anche la visione cinese dell’uomo è "cosmica" ed energetica. L’uomo è collocato tra cielo e terra, tra energia e materia e riassume in sé stesso tutte le caratteristiche del cielo e della terra, del finito e dell’infinito, del materiale e dell’immateriale. E’ in continua comunicazione con le energie cosmiche, stagionali, climatiche e alimentari che penetrano in lui dall’esterno e queste devono essere in equilibrio con quelle interne. Nella pratica l’uomo è rappresentato come energia condensata in sei strati (per dare un’immagine: "a cipolla"), attraversato dai meridiani che sono canali dove scorre l’energia raccolta da ciascun organo o viscere e distribuita al resto del corpo. Si considerano 12 meridiani che hanno punti propri sui quali si può agire per intervenire sui corrispondenti organi e visceri interni e 8 meridiani che conservano e trasportano energia ancestrale e vengono utilizzati per patologie particolari. Si riconoscono cinque organi, a ciascuno dei quali è accoppiato funzionalmente un viscere. L’organo con il viscere corrispondente costituisce una "loggia energetica" (fegato-vescica biliare = loggia Legno; cuore-intestino tenue = loggia Fuoco; milza/pancreas-stomaco = loggia Terra; polmone-intestino crasso = loggia Metallo; rene-vescica urinaria = loggia Acqua). Poi vi sono dei "visceri curiosi" (cervello, midollo, utero, ossa). Ogni loggia energetica dà una peculiare informazione all’energia generale dell’organismo (Qi) e al sangue (Xué), caratterizza un aspetto particolare dell’attività psichica e di relazione del soggetto, governa un particolare organo di senso e presiede ad una facoltà intellettiva e sentimentale del soggetto. Inoltre ciascun sapore e ciascun clima hanno interferenze preferenziali (sia positive che negative) con una loggia energetica piuttosto che con altre. Anche la natura dei cibi (calda, fredda, neutra) può nutrire o deprimere le attività di ciascuna loggia.
L’energia e il sangue circolano incessantemente nell’organismo secondo ritmi e percorsi precisi: ogni loggia ha nell’arco della giornata un’ora di massima pienezza dell’energia e un’ora di minimo energetico e l’energia passa da un organo/viscere all’altro secondo ritmi precisi, per cui l’orario di insorgenza di un disturbo può aiutare a capire lo squilibrio di quale organo sia la causa della malattia.
I cinesi avevano ottime conoscenze di anatomia poiché utilizzavano la dissezione anatomica a fini di studio già 2500 anni fa. Tuttavia l’esame di "pezzi privi di vita" aiuta poco a comprendere la fisiologia dell’organismo e questo spiega perché nel complesso il sistema anatomo-fisiologico della medicina cinese sia così distante dalla medicina occidentale. Questi rapidissimi cenni dovrebbero essere sufficienti a rendere l’idea della diversa prospettiva dalla quale sono osservati i problemi di salute.
La diagnosi viene formulata attraverso l’anamnesi e l’esame obiettivo che servono a rispondere alle domande che costituiscono le "otto regole diagnostiche":
lo squilibrio viene dall’esterno (è esogeno)?
lo squilibrio viene dall’interno (è endogeno)?
si tratta di uno squilibrio Yang?
si tratta di uno squilibrio Yin?
è uno squilibrio da calore? Vero o falso?
è uno squilibrio da freddo? Vero o falso?
è uno squilibrio da pieno?
è uno squilibrio da vuoto?
Si riconoscono come cause di squilibrio e quindi di malattia i seguenti fattori:
energie perverse esterne (caldo, freddo, vento, secchezza, umidità)
errori alimentari (eccesso o carenza quantitativi, natura sbagliata, sapore sbagliato o eccessivo o carente)
errori comportamentali (eccessi di movimento, di sonno, di sesso; sedentarietà, carenza di sesso, di sonno, alterazione dei ritmi circadiani, eccetera)
squilibri interni o endogeni (emotivi, psichici, stress)
Data una qualsiasi noxa la malattia è determinata dalla incapacità di reazione ad essa dell’organismo.
L’ANAMNESI si informa delle caratteristiche della malattia esattamente come la medicina occidentale, in modo pignolo; in più si informa dell’orario di comparsa o scomparsa dei sintomi, delle caratteristiche psichiche, dei gusti preferiti o insopportabili (agro, amaro, dolce, piccante, salato), dei colori da cui si è attratti, della stagione in cui si sta bene e di quella in cui si sta peggio, del clima preferito e di quello che si teme, della natura dei cibi che si assumono (calda, fredda, neutra), della posizione in cui si dorme, dell’atteggiamento che si aveva prima di ammalarsi e su come si è modificato con la malattia (desiderio di luce/ombra, di uscire all’aperto o di stare al chiuso, di parlare o fastidio a farlo, tendenza a rimuginare o incubi o tristezza o irritabilità o insofferenza o ilarità eccessiva, eccetera).
Per esempio di fronte a un dolore è fondamentale sapere, oltre alle caratteristiche del dolore stesso che qualsiasi paziente è portato a riferire (acuto, sordo, gravativo, martellante, bruciante, eccetera) se è accompagnato da senso di calore o di freddo nella zona dolente, se la compressione arreca giovamento o peggioramento, se si va a cercare il fresco o al contrario si copre la parte dolente con pezze calde, se migliora con il movimento o con il riposo: infatti il dolore da pienezza peggiora con la compressione, mentre quello da vuoto migliora, così come il dolore da calore cerca il fresco e quello da vento-umidità-freddo cerca il calore. E così via.
Tutte le domande servono ad individuare:
la possibile causa,
lo squilibrio provocato dalla noxa,
il livello energetico coinvolto,
la loggia più colpita,
l’organo o viscere più alterato,
le funzioni più compromesse,
la reazione generale dell’organismo all’insulto (prognosi).
L’ESAME OBIETTIVO serve per pervenire alla diagnosi, dato che l’anamnesi da sola è insufficiente. L’esecuzione dell’esame obiettivo nella medicina tradizionale cinese è in buona parte peculiare. Rimandiamo ai testi di metodologia clinica di medicina tradizionale cinese (v. bibliografia) per i dettagli.
Schematicamente esso consiste nelle seguenti fasi:
1. ispezione: si valuta la "facies" del paziente cercando di dedurre dall’aspetto fisico, dalla postura, dall’incarnato, dalla distribuzione dei peli, dalla robustezza delle unghie, dalla presenza e localizzazione di eventuali lesioni cutanee, dal modo di muoversi, di guardare, di parlare quali siano le energie prevalenti nel soggetto in esame. Peculiari e assai importanti sono l’esame dell’occhio, dell’orecchio e ancora di più l’esame della lingua. Infatti in questi organi si riconoscono proiezioni somatotopiche che permettono di localizzare l’origine dei disturbi. In particolare della lingua si apprezzano la consistenza, il colore, il grado di umidità, la quantità e le caratteristiche dell’induito (o patina), la mobilità, l’eventuale presenza di asimmetrie, impronte dentali, lesioni, tremolii, rigidità: esistono capitoli interi, nei trattati, dedicati all’esame e all’interpretazione dei reperti della lingua.
2. palpazione: questa fase è in parte comune alla palpazione della medicina occidentale (palpazione della cute, delle masse muscolari, degli organi ipocondriaci e dei visceri addominali, palpazione e percussione del torace). Del tutto peculiare è invece la palpazione dei punti dei meridiani (si cercano pastosità o alterazioni di consistenza del sottocutaneo, dolorabilità alla palpazione dei punti, ecc.) e soprattutto la palpazione dei polsi. La pulsologia è un settore molto complesso e difficile da apprendere, di cui esistono ampi trattati e scuole pluriennali. Un detto cinese dice che "l’allievo impara a diagnosticare attraverso i polsi quando il maestro muore" vale a dire dopo molti decenni di pratica. In poche parole: a livello dell’arteria radiale vi sono tre punti (chiamati polso pollice o distale, polso barriera o intermedio e polso piede o prossimale) a livello dei quali sono apprezzabili i "soffi" di organi e visceri.
Ad ogni polso corrisponde una loggia energetica di cui si apprezzano il viscere-Yang in superficie e l’organo-Yin in profondità (quindi 12 polsi su tre punti di palpazione a destra e tre a sinistra: cinque logge più una "superloggia" = 6 logge, su ciascun punto un organo in superficie e un viscere in profondità). Dall’esame dei polsi è possibile ricavare una quantità inimmaginabile di informazioni sullo stato di salute del malato e rispondere alle otto regole diagnostiche. Sono stati classificati diciotto reperti pulsologici principali, sette polsi aberranti o mortali, più molti altri di meno frequente riscontro: corrispondono alle sensazioni che si possono avere sotto le dita palpando i polsi in riferimento alla profondità, la velocità, il ritmo, l’ampiezza, la lunghezza, la forza, la forma dell’onda sfigmica.
Questa tecnica palpatoria non è del tutto estranea alla medicina occidentale: infatti la scuola galenica (in auge per 1500 anni, fino al secolo dei Lumi) insegnava anche la presa dei polsi per porre diagnosi; inoltre a partire dal XVI secolo si diffusero in Francia, e da lì al resto dell’Europa, alcune nozioni importate dall’Oriente. Perciò anche i medici europei "leggevano" le disfunzioni dei vari organi palpando i polsi. Nella commedia di Moliére "Il malato immaginario" c’è una scena in cui questo è chiaramente rappresentato: Toinette travestita da luminare mima la visita medica prendendo un polso del finto malato e dicendo "Vi hanno detto che il problema è nel fegato? Nella milza? Tutti ignoranti! Esso sta nel polmone". Ancora oggi si apprende nella semeiotica che "il polso radiale va tenuto con tre dita esploranti" anche se questo dato appare del tutto superfluo: è la reminiscenza della pulsologia in uso fino al secolo dei Lumi.
3. olfattazione: consiste nell’annusare il paziente e i suoi secreti. Infatti ogni tipo di alterazione delle energie corporee modifica in modo caratteristico l’odore emanato dal paziente (odore fetido, acre, di pesce, rancido, tipo "urina di topo" eccetera). Dall’odore si può essere aiutati a formulare la diagnosi.
4. auscultazione: si ausculta la voce (timbro di voce, volume, velocità di eloquio, modalità di emissione della voce, eccetera), il respiro, la tosse, cercando di coglierne le caratteristiche e interpretandole secondo le regole dei movimenti energetici.
Per quanto riguarda le ULTERIORI INDAGINI si dirà che esse si basano sull’analisi delle feci e delle urine, ma anche sulla valutazione delle energie cosmiche stagionali e straordinarie.
La diagnosi corretta, cioè il capire esattamente che tipo di squilibrio energetico è in causa, conduce infallibilmente alla terapia corretta. Come è scritto nel "So Wen" ("Canone di medicina interna dell’imperatore Giallo", considerato uno dei più antichi testi di medicina cinese): "Se non vi è errore nella diagnosi, l’errore sarà impossibile nella cura" (cap.5).
OMEOPATIA
Parlare di omeopatia è difficile perché con il termine "omeopatia" si intendono comunemente pratiche molto diverse concettualmente ed operativamente quali l’omeopatia unicista, l’omeopatia complessista e l’omotossicologia (per quanto di recente sia stata riconosciuta ufficialmente la sostanziale differenza tra omeopatia unicista e omotossicologia, è altrettanto vero che i cosiddetti "omeopati" che attualmente operano praticano, in quanto omeopati, entrambe le branche). Noi parleremo prevalentemente di omeopatia unicista, poiché l’omeopatia omotossicologica può essere assimilata - per quanto concerne la metodologia diagnostica - alla medicina convenzionale.
L’omeopatia si basa sul principio di similitudine (similia similibus curentur), per cui una sostanza che in un soggetto sano provoca determinati disturbi è utilizzata, opportunamente diluita e "dinamizzata", per curare quegli stessi disturbi qualora spontaneamente presentati da un malato. Così gli anticolinergici quali aconito o belladonna sono utilizzati nei quadri neurovegetativi con sintomi "anticolinergici", l’istamina nelle reazioni allergiche da ipersensibilità immediata, i caustici nelle ulcerazioni, i veleni di serpenti vasculotossici nelle vasculiti e così via. Per quanto recentemente si stiano moltiplicando studi che giustifichino razionalmente i presupposti di questa disciplina, la base dell’omeopatia è essenzialmente empirica, fondata sull’esperienza e la riproducibilità degli stessi effetti in soggetti diversi.
Ecco, schematicamente, come si procede.
Una sostanza, che si vuole testare, viene diluita e succussa opportunamente (nella tecnica omeopatica non è la diluizione la sola caratteristica, ma soprattutto la dinamizzazione, cioè la sostanza viene agitata con potenza e frequenza stabilite ad ogni diluizione, in modo da conferirle una specifica energia cinetica che è quella che poi risulterebbe necessaria per il trasferimento dell’informazione dal soluto al solvente). Questa sostanza diluita e opportunamente succussa, viene somministrata a soggetti volontari sani, i quali debbono annotare meticolosamente qualsiasi sensazione, variazione fisica, comportamentale o dell’umore notino da subito dopo l’assunzione del rimedio fino a un numero di giorni precedentemente stabilito (una settimana o di più). Vengono poi confrontate le annotazioni dei diversi soggetti e vengono raccolte le variazioni più comuni e più intense. Questa tecnica si chiama "PROVING". Le variazioni, indotte dal rimedio in tutti i soggetti sani che l’hanno assunto, vengono raccolte nella MATERIA MEDICA OMEOPATICA. Pertanto la Materia medica è la raccolta, in ordine alfabetico, dei rimedi testati con proving e della descrizione minuziosa dei sintomi e delle modificazioni dell’umore provocati da ciascun rimedio in soggetti sani. Poiché più rimedi possono dare lo stesso sintomo, sono stati poi compilati, in base ad amplissime casistiche, i REPERTORI OMEOPATICI che riportano per ciascun sintomo significativo i principali rimedi che lo possono provocare nel sano, in ordine di importanza e di frequenza. La Materia Medica, e di conseguenza i Repertori, sono in continua espansione, date le numerose nuove sostanze utilizzabili; in teoria tutte le sostanze esistenti possono essere prese in considerazione per allestire rimedi omeopatici.
La metodologia diagnostica omeopatica ha lo scopo di trovare il rimedio adatto, e la diagnosi omeopatica coincide con la prescrizione del rimedio. Non vi sono pertanto in omeopatia unicista diagnosi tipo "sindrome della menopausa", "broncopolmonite", "gastrite" o altro, ma prescrizioni, "sintomi tipo il tal rimedio" (intendendo "sintomi simili a quelli che il tal rimedio provoca in persone sane"): sintomi tipo Lachesis, o tipo Belladonna o altro. Poiché i medici che praticano l’omeopatia sono in genere educati alla metodologia convenzionale, solitamente utilizzano le descrizioni nosologiche convenzionali per inquadrare i pazienti, ma questo inquadramento non è strettamente omeopatico. Infatti in omeopatia due pazienti con la stessa malattia convenzionalmente diagnosticata possono essere trattati con rimedi diversi perché la malattia si esprime in modo soggettivamente diverso. Il metodo omeopatico consiste nel cercare nel modo più preciso possibile le coincidenze tra il quadro clinico presentato dal paziente e il quadro clinico che il rimedio che si vuole utilizzare provoca nelle persone sane quando somministrato a bassa diluizione.
Per giungere a questa identificazione si utilizzano l’anamnesi e l’esame obiettivo, che vengono in parte svolti contemporaneamente, annotando meticolosamente i reperti su una scheda e confrontando alla fine i dati raccolti con quanto contenuto nella Materia Medica e nei Repertori omeopatici.
L’ANAMNESI omeopatica è in buona parte peculiare, essendo condotta in modo più meticoloso rispetto a quella convenzionale. Nell’anamnesi omeopatica assumono infatti rilevante importanza dettagli delle abitudini o del vissuto del malato che normalmente vengono trascurati.
L’inquadramento generale è sovrapponibile a quello convenzionale: anamnesi patologica prossima e remota, fisiologica, familiare. Il paziente si esprime liberamente, non viene interrotto, vengono annotati i termini con cui si esprime per descrivere il suo disturbo, viene annotato come si muove, il tono e il volume della voce, la velocità, la fluidità e la ricchezza dell’eloquio. Tra tutti i sintomi e gli stati d’animo riferiti vengono ricercati quelli "significativi" per la repertorizzazione, quelli che verranno utilizzati per farsi guidare nella scelta del rimedio (che sono quelli più "strani" e provocati nel sano da uno solo o pochi rimedi). In particolare viene data molta importanza all’orario di peggioramento dei sintomi e a quello di miglioramento (spesso i pazienti non prestano attenzione a quest’ultimo aspetto, cioè a periodi della giornata in cui stanno meglio), ai cambiamenti dell’umore, a come il paziente vive i propri disturbi, all’attrazione o repulsione per determinati cibi, alla sensazione di fastidio per le correnti, o per il caldo o per gli abiti stretti o per gli abiti troppo ampi, eccetera.
Schematicamente, il medico omeopata, nel condurre l’anamnesi, si informa di:
perché è venuta la malattia? ("Cur?")
che tipo di persona l’ha contratta? ("Quis?")
che malattia è, cioè che sintomi dà al malato? ("Quid?")
dov’è localizzata? Interessa la localizzazione dei disturbi e anche la lateralità o se prima di colpire entrambe le parti siano cominciati a destra oppure a sinistra. ("Ubi?")
andamento dei sintomi: aggravamento/miglioramento in determinati orari, con determinati climi o stagioni, in concomitanza con avvenimenti della vita quotidiana o funzioni fisiologiche, con certe variazioni dell’umore, eccetera. ("Quando? Quomodo?")
sintomi concomitanti, comparsi assieme alla malattia ma apparentemente non correlabili ad essa ("Quibus auxiliis?")
Dopo avere annotato tutto ciò che il paziente riferisce, si dovranno selezionare i sintomi "utili". I sintomi vaghi, non caratteristici vengono scartati. Vengono stimati buoni sintomi-guida quelli che esprimono la natura del malato più che la natura della malattia (ad esempio: la paura di essere in punto di morte durante una crisi di angina pectoris è espressione della malattia, mentre la stessa sensazione per un dolore ad una caviglia è espressione del malato; la sete intensa in un diabetico è espressione della malattia, mentre la sete intensa in un paziente non diabetico che presenta insonnia è espressione del malato, e così via). I sintomi vengono poi ordinati secondo una "gerarchia" di importanza. Non vi è perfetta concordanza tra i vari Autori su quali sintomi scegliere per la repertorizzazione e sull’importanza da attribuire loro; infatti questo è notoriamente uno dei più grossi problemi di metodologia omeopatica.
Per esempio Dujany propone questa classificazione, da molti non accettata:
sintomi mentali.
sintomi eziologici (le cause di malattia: ambiente, emozioni, alimenti, comportamento, vita sessuale, intossicazioni, interventi chirurgici, traumi, eccetera)
sintomi generali, ambientali e/o climatici.
i desideri e le avversioni alimentari.
i sintomi concernenti il sonno, compresi i sogni qualora ricorrenti o particolari.
la genitalità e la sessualità e le loro espressioni.
le escrezioni e secrezioni di qualsiasi genere e le loro caratteristiche.
Recentemente Candegabe e Carrara hanno proposto una classificazione dei sintomi in cui i sintomi, a seconda del loro "peso", ottengono punteggi diversi:
|
Sintomi STORICI (presenti da sempre) |
Sintomi INTERMEDI (presenti da tempo) |
Sintomi ATTUALI (appena comparsi) |
|
|
Sintomi MENTALI |
9 |
7 |
3 |
|
Sintomi GENERALI |
8 |
5 |
2 |
|
Sintomi LOCALI |
6 |
4 |
1 |
Naturalmente sono da tenere presenti anche tutti gli altri fattori esaminati in precedenza, tra cui la cosiddetta "modalizzazione" dei sintomi (stagionalità, ora, intensità, associazioni con altri sintomi, eccetera). Maggiore importanza viene data ai sintomi mentali (o a quelli eziologici secondo altre scuole), minore alle caratteristiche delle escrezioni o secrezioni: non tutti i sintomi hanno uguale rilevanza per cercare il rimedio più adatto.
Per quanto riguarda l’ESAME OBIETTIVO, esso è sovrapponibile a quello "convenzionale", ma presta maggiore importanza alla postura, all’incedere, all’incarnato, alla cute e agli annessi, alla lateralità di eventuali lesioni cutanee, alla temperatura cutanea, alla sudorazione. Anche in omeopatia, come nella medicina cinese, assume molta importanza l’esame della lingua: la forma, le dimensioni, la consistenza, il colore, il grado di umidità, le caratteristiche della patina (o induito), la presenza di lesioni o alterazioni, la mobilità, la presenza di impronte dentali. Occorre però sottolineare che tale esame era importante anche nella semeiologia "convenzionale" e solo le ultime generazioni di medici lo trascurano (chi non ricorda le visite mediche con "Tiri fuori la lingua?").
A questo punto si procede a quella che è chiamata repertorizzazione, cioè si guarda per ciascun sintomo o segno significativo scelto quali rimedi lo provocano nel sano: alla fine, confrontando i rimedi suggeriti per i vari sintomi, si sceglie quello che è in grado di provocarne di più tra quelli presentati dal paziente. Si cerca infine la conferma verificando se l’insieme dei sintomi provocati dal rimedio scelto (patogenesi) definisce un ritratto che si avvicina al paziente da curare. Se vi assomiglia solo in parte definiremo quel rimedio "simile", se vi corrisponde completamente definiremo quel rimedio "simillimum", il solo capace di risolvere completamente la situazione morbosa. Pertanto nella medicina omeopatica la formulazione della diagnosi coincide con la prescrizione terapeutica.
Per quanto riguarda le ULTERIORI INDAGINI se ne farà soltanto un cenno. Esistono svariate metodiche (come la kinesiologia e varie apparecchiature bioelettroniche) che, valutando la contrattilità muscolare o misurando la conducibilità elettrica cutanea, sono in grado di ricavare informazioni di tipo elettromagnetico dall’organismo del malato e di interpretarle secondo una visione energetica derivata dall’agopuntura cinese e dall’omeopatia. Tali metodiche, mai validate con procedimenti scientificamente accettabili, utilizzano rimedi omeopatici ed organo-derivati diluiti e dinamizzati per pervenire alla diagnosi. Tra queste citiamo l’Elettro Agopuntura secondo Voll (EAV), il VEGA-test (VRT), il SEG-test, il DBE e tanti altri.
COMPARAZIONE TRA I VARI METODI CLINICI ATTRAVERSO UN ESEMPIO: L’IN-FLUENZA
Per quello che riguarda le caratteristiche di patologie presentate dal paziente, si può notare che nella medicina convenzionale l’anamnesi sonda le caratteristiche dei sintomi e/o segni solo fintanto che essi aiutano a pervenire alla diagnosi, non ritenendosi più di tanto utile scendere nei dettagli della soggettività di espressione di una malattia già ben inquadrata. Invece nell’ottica omeopatica o in quella cinese questi elementi sono importantissimi per attuare la terapia più adatta e per questo vengono meticolosamente indagati: non solo "che malattia è?" ma anche "come si manifesta in questo particolare paziente?".
Per cercare di rendere un po’ più concreto questo discorso, prendiamo un esempio clinico e affrontiamolo con le tre prospettive proposte.
Scegliamo un esempio banale: la sindrome influenzale. Essa può manifestarsi in più modi, come ogni medico sa; vediamo un paio di quadri clinici:
A) Ci sono pazienti nei quali l’influenza esordisce bruscamente con cefalea pulsante che migliora con la compressione ma peggiora con il freddo, brividi scotenti, spossatezza, febbre alta di tipo remittente, più elevata nel primo pomeriggio e nelle ore notturne e associata a irrequietezza, cute arrossata, calda e bruciante con estremità fredde e voglia di stare coperti, dolori diffusi (lombalgie, nevralgie trigeminali e alle gambe), faringodinia con linfomegalia satellite, secchezza delle mucose, tosse secca peggiorata dai movimenti del capo con dolori costrittivi al torace e alla gola, ipersensibilità al tatto, insofferenza per la luce e i rumori, occhi arrossati e brucianti, desiderio di penombra e solitudine, sonno profondo con sogni agitati, sete intensa di bevande fredde, mangiando qualcosa il malato sta meglio, ha dolori allo stomaco, stranguria e pollachiuria; questo quadro influenzale è quindi caratterizzato dalla cefalea, dai dolori lombari, dall’iperestesia cutanea, dalla febbre, dalla tosse e dalla secchezza delle mucose, dai problemi oculari.
B) In altri casi invece l’esordio può essere lento, con malessere generale e astenia ingravescenti, febbre che sale lentamente e scarso brivido, raffreddore, tosse secca e abbassamento di voce, dolori al torace, labbra secche e screpolate, artralgie importanti, cefalea gravativa e senso di ottundimento mentale, peggioramento dei dolori con il movimento eppure irrequietezza che spinge a muoversi, voglia di fresco, di tenere le finestre aperte, può esserci anoressia anche perché dopo mangiato il paziente si sente peggio per meteorismo, nausea e dolore gastrico, c’è voglia di bere grandi quantità d’acqua seguita da rifiuto dell’acqua, lingua secca con spessa patina bianca; gli occhi, nonostante la febbre elevata non sono così arrossati né brucianti; c’è stipsi, possono esserci disturbi urinari con stranguria, poliuria o al contrario oliguria, è presente prostrazione psichica e depressione. Possono aversi complicanze pleuropolmonari. Questo secondo quadro è caratterizzato pertanto dal malessere, la febbre elevata, la secchezza delle mucose, i disturbi delle prime vie aeree e digestivi, la prostrazione.
Si potrebbero descrivere altri quadri (a disturbi prevalenti gastrointestinali, con labilità del tono neurovegetativo e frequenti lipotimie, e altri ancora), ma due sono già sufficienti per il confronto.
Per un medico "convenzionale" tutti questi sintomi hanno scarsa rilevanza, una volta che sia stabilito che si tratta di influenza (e nel porre diagnosi ci si aiuta anche col fatto che questi sintomi insorgano nei mesi freddi, in piena epidemia influenzale): vengono considerati come variabilità della malattia, ma non influenzano la condotta terapeutica. Si sa che alcuni malati potranno presentare delle complicanze, ma le caratteristiche di esordio non aiutano a prevederle. Pertanto tutti i pazienti con malattia acuta febbrile verranno sorvegliati con la medesima attenzione, valutando il rischio di complicanze solo con criteri epidemiologici (anziani, concomitanti malattie debilitanti, eccetera) ed in base all’andamento clinico.
Per il medico "cinese" questi due quadri corrispondono a reazioni molto diverse dell’organismo all’insulto patogeno (che nel caso dell’influenza è in genere un attacco di energia perversa esterna da freddo-umidità), con prognosi differente, quella del quadro B più grave. Infatti in medicina cinese si riconoscono nell’uomo sei strati energetici concentrici, che qualora colpiti originano sintomi e segni diversi (v. tabella I).
Tabella I: classificazione delle malattie acute febbrili
|
STRATO ENERGETICO MERIDIANI |
SINTOMI DESCRITTI NEI TESTI ANTICHI DI MEDICINA CINESE ("Nei ching" e "Trattato delle malattie febbrili del freddo nocivo") |
|
|
1 |
TAE YANG vescica ur./intest. Tenue |
dolore e rigidità nucale e lombare, cefalea posteriore, timore del freddo, febbre con brivido, polso superficiale |
|
2 |
YANG MING stomaco/grosso intestino |
febbre, forti dolori oculari, accessi febbrili vespertini, delirio, sete, stipsi, secchezza del naso, insonnia |
|
3 |
CHAO YANG vescica biliare/triplo riscald. |
offuscamenti, febbre e brividi alternati, dolori toracici, petto e fianchi gonfi e dolenti, bocca amara, gola secca, sordità |
|
4 |
TAE YIN Milza-pancreas/polmone |
gonfiore addominale, eruttazioni, gola secca, nausea e vomito; se si aggrava diarrea e dolori addominali, lingua gonfia e patinosa |
|
5 |
JUE YIN fegato/pericardio |
sensazione soffocante di pienezza, anoressia, caldo in alto e freddo in basso, sete intensa, diarrea e vomito profusi, dimagramento |
|
6 |
CHAO YIN ("asse della vita") rene/cuore |
bocca secca, sete, timore del freddo non migliorato dal caldo, desiderio di dormire sempre, torpore, decubito a cane di fucile, braccia e gambe ghiacciate con freddo che risale, polso fine e tenue |
Nell’esempio citato il quadro clinico A corrisponde ad un assalto agli strati più superficiali (il brivido è segno di difesa della pelle che cerca di impedire all’energia patogena di penetrare) con penetrazione di freddo all’interno del corpo e calore in superficie e sintomi prevalentemente degli strati 1 e 2, mentre il quadro B mostra un attacco già all’inizio più profondo con disturbi che rivelano coinvolgimento degli strati 3 e 4. La prognosi pertanto è più seria, anche se pure il primo quadro può evolvere verso forme più gravi. Il trattamento sarà logicamente diverso nei due casi, e comunque tempestivo, basato su norme igieniche, prescrizioni dietetiche e puntura o riscaldamento di determinati agopunti scelti in base ai sintomi e all’esame della lingua e dei polsi.
Per il medico "omeopata" tutti i sintomi presentati dal paziente hanno molta importanza e vengono presi in considerazione: l’esordio, le caratteristiche della febbre, la presenza di brividi, le caratteristiche dei dolori, la cenestesi, eccetera. Così al paziente che presenta il quadro clinico A verrà prescritto un certo rimedio (per esempio Belladonna), mentre al paziente che presenta il quadro clinico B ne verrà prescritto un altro (per esempio Bryonia). Se il rimedio è corretto, si avrà pronta guarigione e nessuno dei pazienti presenterà complicanze.
CONCLUSIONI
Con la rapidità imposta dall’esiguità dello spazio abbiamo cercato di ripercorrere le tappe fondamentali dell’acquisizione dei dati in approcci medici diversi illustrando rapidamente i fondamentali presupposti teorici e patogenetici di ciascuna medicina e concludendo con un confronto tra le varie metodiche attraverso un esempio clinico.
Riassumendo in modo didascalico, seppur forse troppo semplicistico, si potrebbe dire che la medicina "convenzionale" cura le malattie, la medicina tradizionale cinese cura le malattie come si presentano nei singoli malati mentre l’omeopatia cura i singoli malati.
La medicina "convenzionale" risulterebbe pertanto la più "oggettiva", l’omeopatia la più "soggettiva", quella cinese una via intermedia.
Da questa approssimazione si possono ricavare alcune considerazioni:
- il medico è tanto più sicuro della diagnosi (e pertanto della terapia da prescrivere) quanto più essa è oggettiva e provata: pertanto la medicina "convenzionale" - nella misura in cui permette di pervenire alla diagnosi - è quella più utile al malato e più tranquillizzante e confortante per il medico;
- il malato è più gratificato da una medicina che dia importanza a tutte le sfumature del suo vissuto senza colpevolizzarne o sminuirne alcuna perché in fondo chiede di essere capito e ascoltato ancor prima che guarito e pensa che il medico che lo capisce di più deve saperlo curare meglio;
- i medici "convenzionali" che a un certo punto della loro vita abbiano aggiunto al loro bagaglio di conoscenze mediche le prospettive dell’omeopatia o della medicina tradizionale cinese (o di altre medicine cosiddette "naturali") si sono sentiti arricchiti nella loro capacità di ascolto, di valutazione dei sintomi, di collegamento tra eventi morbosi, di comprensione del malato (e di se stessi), senza che questo li abbia impoveriti come "medici".
In conclusione pertanto si può dire che pur guardando ai problemi di salute da prospettive diverse, le varie medicine non sono contrastanti l’una con l’altra, potendosi invece reciprocamente arricchire. Di fronte alla crisi che la medicina sta attraversando (accanto allo sviluppo enorme della tecnologia e al vertiginoso aumento dei mezzi diagnostici e dei presidi terapeutici a disposizione, concomita una certa incapacità a gestire bene le risorse disponibili e un profondo disagio nel dover delimitare i compiti e i confini dell’agire medico) le prospettive che le medicine non convenzionali offrono possono, se accettate, aiutare a riprendere contatto con le persone malate e con il patrimonio esperienziale della medicina, la quale, pur guidata e sostenuta dal metodo scientifico e dalla statistica, è e resta una scienza empirica (il termine "empirico" qui è inteso come "fondato sull’esperienza", e non ovviamente come "privo di prove e di dati oggettivi").
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Bellavite P.: Biodinamica. Tecniche Nuove Editore, Milano, 1998
Dioguardi N. - G.P. Sanna: Moderni aspetti di semeiotica medica. SEU editrice - Roma
Ferlinz R.: Diagnostica differenziale in Medicina Interna - Masson editore - Milano
Friedman H.H.: Diagnosi medica per problemi. - Il pensiero scientifico editore - I libri con la spirale - Roma
Auteroche B. - Navailh P.: La diagnosi in Medicina Cinese. Edi-Ermes editrice - Milano
Di Concetto G. - Muccioli M. - Sotte L.: Diagnosi Clinica Cinese. Quaderni di Medicina Naturale VI (Suppl. a Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese n° 60 - 2/1995)
Kaptchuk T.J.: Medicina Cinese: fondamenti e metodo. La tela che non ha tessitore. - Edizioni Red - L’altra medicina/studio 12 - Como
Pippa L. - De Giacomo E. - Muccioli M. -Sotte L.: Semeiologia cinese. Quaderni di Medicina Naturale VII (Suppl. a Rivista Italiana di Medicina Tradizionale Cinese n° 63 - 1/1996)
Veith Ilza (a cura di): Huang Ti Nei Ching So Wen: Il canone di medicina interna dell’Imperatore Giallo. -Edizioni Mediterranee - Roma
Bellavite P. - Signorini A.: Fondamenti teorici e sperimentali della medicina omeopatica - IPSA editore - Palermo
Candegabe E: Materia Medica Comparata. Edizioni Red. - Como
Candegabe ME, Carrara HC: Approssimazione al Metodo pratico e Preciso della Omeopatia Pura. Centro Internazionale della Grafica - Venezia
Dujany R.: Materia Medica Omeopatica. Edizioni Raffaello Cortina, Milano
Dujany R.: Omeopatia. - Edizioni Red - L’altra medicina/studio 2 - Como
Kent J.: Materia Medica - Edizioni Red - L’altra medicina/studio 8 - Como
Roberts H. A.: Omeopatia - I principi e l’arte del curare. - Edizioni Mediterranee – Roma