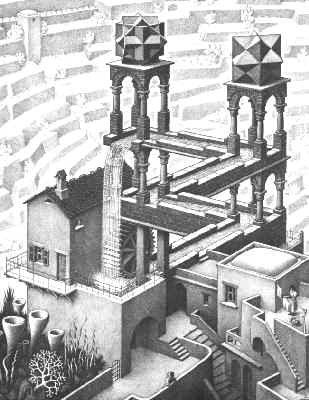
A.M.S.A. - SO-WEN - A.F.A.C.
La patologia dei
"Quattro Strati":
generalità, diagnosi e terapia
Dente De Berardinis, Rosa Brotzu, Roberto Gatto
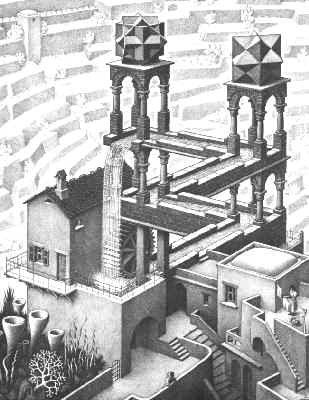 |
A.M.S.A. - SO-WEN - A.F.A.C. La patologia dei Dente De Berardinis, Rosa Brotzu, Roberto Gatto |
Riassunto:
Si analizzano i sintomi ed il trattamento, in agopuntura, fitoterapia e dietetica, della
patologia dei 4 Strati. Oltre alla relazione reciproca fra queste zone, si precisano il
rapporto con le 5 Sostanze e quelli con i diversi Organi e Visceri.
Parole Chiave:
quattro strati, weifen, qifen, yingfen, xuefen, agopuntura, fitoterapia cinese, dietetica
energetica
"Anche se io parlassi il linguaggio degli angeli,
risuonerei come un bronzo vuoto, se non possedessi l’amore"
Deuteronomio, citato da A. Zulavsky in "Film Blu", 1996.
Introduzione
Mentre la patologia dei sei livelli era già nota nel 220 d.C. (è stata proposta da Zhan Zhong Jing nel suo Shan Han Za Bing Lung , suddiviso in Shang Han Lun e Jin Kui Yao Fang Lun da Wang Shu-Hè nel 1060), quella dei 4 strati (si fen) è più recente, elaborata durante la dinastia Qing (o mancese) da Ye Tan Shi e dai suoi discepoli nel 1746 (nel trattato Wen Re Lun), espressamente dedicato alle patologie "da calore". Il testo, basato sul Nei Jing e su esperienze dirette dell’A, individua 4 diverse zone che rappresentano una stratificazione delle aree funzionali, dall’esterno all’interno, dell’organismo (Lu Gwei Djen, Aghi Celesti, Enaudi, Torino, 1987; Boschi G., Medicina Cinese, Ed. Edra, Genova, 1997; Encyclopedie Medicine Naturelle, Tome I:Acupuncture, Ed. Techniques, Paris, 1989). Mentre la teoria dei "sei livelli" ha un valore molto generale, quella dei 4 strati è centrata sulle diverse sostanze:
| Lo strato Wei corrisponde alla Weiqi |
Lo strato Ying alla Yingqi |
Lo Strato Qi alla Zheng Qi |
Lo Strato Xue Al sangue |
Nella loro patogenesi le malattie esterne (e non solo quelle infettive
o contagiose) tendono a penetrare dal livello più superficiale a quello più profondo e
così ad aggravarsi. Se vi sono condizioni di "vuoto" dell’energia corretta
antipatogena sono possibili salti di livello o attacchi più profondi che risultano
particolarmente gravi.
Mentre nel caso della patologia dei "liu qi" (sei livelli) si parla di
"sindromi da freddo", in quella dei "si fen" di forme da calore.
Questo non perché nella pratica la prima sia contrassegnata dal freddo (anzi nel caso di
shao Yang, Yang ming, alcune varietà d shao jue Yin domina il calore) e la seconda da
calore (non molto calore contrassegna l’attacco di Weifen), ma piutosto per ragioni
patogenetiche.
Secondo alcuni AA (G. Andrés: Etiopatogenesi generale in MTC, policopie, Ed. Gruppo San
Li, 1991; Porkert M. & C. Ulmann, Chinese Medicine, Ed. W. Marrow, New York, 1988) si
parla di sei livelli quando i morbigeni esterni causano anomalie nella circolazione
energetica (il freddo rallenta e blocca la circolazione di Qi e Xue); invece di 4 strati
quando detti eccessi (liu Yin) distruggono la materia e causano danni strutturali (il
calore ed il fuoco danneggiano organicamente il corpo).
Attualmente, soprattutto in campo di patologie esterne (waike), si
preferisce la classificazione secondo i 4 strati piuttosto che quella a sei livelli,
segnalando, tuttavia, che nelle patologie croniche e persistenti gli strati sono coinvolti
assieme agli zang/fu (D. Colin e A. Barry, L’Acupuncture du A au Z, Ed. BA, Paris,
1990; Shen De-hui et al.: Manuale di Dermatologia in MTC, Ed. C.E.A., 1997).
Poiché poi nella pratica clinica (affezioni dermatologiche, delle alte vie respiratorie,
degli occhi, ecc.) le manifestazioni formano un continuum di sintomatologia i 4 strati
sono sovente divisi in due coppie:
Wei e Qi
Ying e Xue
La prima coppia è considerata Yang, la seconda Yin, inoltre il primo
accoppiamento si riferisce ad una dialettica fra Difesa e Nutrizione, il secondo fra
Energia e Sangue (Kespì, L’Acupuncture, Ed. Maissonneuve, Moulin les Metz, 1982).
Esistono tuttavie altri collegamenti funzianili e dinamici che incrociani fra loro i
termini delle due coppie:
Wei/Ying sono deputati alla reciproca relazione fra difesa e nutrizione. Quando vi sia
poca energia Ying nutrizionale) il corpo possiede poca weiqi per difendersi. Va ricordato
che la Weiqi circola prevalentemente nei meridiani Tendino-muscolari (Jin Jing) e la Ying
Qi nei Luo. Nei distinti circola sia Wei che Yingqi e pertanto questo gruppo di meridiani
viene impiegato nelle patologie da turb contemporanee di Ying e Weiqi (come nelle malattie
autoimmunitarie) (J. Yuen: Meridiani secondari, policopie, Ed. A.M.S.A., Roma, 1988; R.
Low, Secondary Vessels in TCM, ED. Churchill-Livingstone, Edimburgh, 1983).
Qi/Xue il Qi mette in movimento lo Xue (Ling Shu) ma è lo Xue a
trasportare il Qi nell’intero organismo.
Secondo i testi cinesi più completi possiamo riassumere (sotto il profilo struturale e
funzionale) quanto segue (Nguyen Van Nghi: Pathologie et Pathogenie Energetique en
Medicine Chinoise, Ed. Don Bosco, Marsiglia, 1977; Chen Kay An: Pathologie génerale e
diagnostic en Medicine Chinoise, Ed. Maissonneuve, Moulin les Metz, 1983):
| WEIFEN: E’ Yang nello Yang, corrisponde alle superficie ed ai piccoli vasi (capillari o microcircolo terminale. |
QIFEN: E’ Yin nello Yang e corrisponde ai meridiani secondari. |
YINGFEN: E’ Yang nello Yin e corrisponde ai meridiani principali. |
XUE FEN: E’ Yin nello Yin e corrisponde ai grandi vasi sopratutto di tipo arterioso |
Le 4 zone stabiliscono relazioni strette con i meridiani, le cinque
sostanze preziose (wu bao) ed i diversi organi (zang/fu).
I meridiani principali e secondari (jing/luo) sono i vettori del soffio verso le 4 zone,
ovverro collegano le zone alle strtture organiche profonde individuali.
Le diverse sostanze sono in relazione stretta con le 4 zone. Abbiamo già visto le relezioni fra zone e coppia Qi/Xue. Circa lo Shen va detto che da esso dipende la capacità reattiva dell’organismo (la perfetta patergia è definita da Li Shi Zhen Shenzheng). Il Jing è la materia preziosa che compone tutte le zone dell’organismo ed una debolezza del Jing (congenito o acquisito) comporta una meiopragia delle 4 zone.
Più dettagliata e complessa è la relazione fra sifen e liquidi corporei.
Questi liquidi vengono messi in circolazione dal TR e la loro caratteristica è di essere sempre costanti nella loro qualità e di ssere perfettamente ripartiti in tutto il corpo (C. Rempp, Rev. Fr. D’Acupunt., 1995, 78:21-31). Sappiamo che i liquidi sono distinti in superficiali (chiari e visibili) detti Jin e profondi (torbidi ed invisibili) detti Ye e la loro fisiologia prevede l’intervento, soprattutto, del TR. Della Milza, del Polmone, del Rene e della Vescica (che li ripartisce territorialmente). Essi rappresentano una riserva di energia e sangue (Mollard Y. E Maiola M.: L’uomo prima della nascita, Ed. So-wen Jaca Book, Milano, 1995) e le loro funzioni sono essenzialmente due:
| armonizzare ed equilibrare energia e sangue |
nutrire e lubrificare l’intero organismo, fin nei più reconditi recessi interstiziali ed intercellullari ( i couli); sicché morbidezza della pelle, elasticità delle articolazioni, lubrificazione degli organi e degli orifizi mucosi si debbono al loro intervento (è per questo motivo che la Scuola Californiana di Medicina Orientale li paragono ai nostr ormoni). |
Circa la relazione con le zone corporee è interessante lo studio (degli anni ottanta) di Roustan, a partite dalle ricerche della Scuola di Shanghai.
Poiché i liquidi superficiali sno limpidi, visibili e rapidi essi sono definiti Yang (Jin Yang) e vanno a nutrire, lubrificare, rinvigorire le 2 zone Yang: Wei e Qi Fen.
Invece i liquidi profondi sono torbidi (Zuo Ye), lenti, interni quindi Yin (Yin Ye) e destinati alla nutrizione delle 2 zone profonde: Ying e Xue Fen.
Pertanto (G. Andrés: Il chiaro ed il torbido in medicina cinese, policopie, Ed. AMSA, 1998) i Jin Ye sono l’aspetto fondamentale di un individuo, assicurano la coerenza di tutto l’organismo e rappresentano una riserva di energia e di sangue.
Per questo i soggetti che o sudano troppo (per condizioni climatiche caldo-umide o debolezze costituzionali) o hanno carenze di liquidi per cause diverse (uso di antibiotici o farmaci riscaldant, dieta troppo ricca di sapori piccanti ed amari, ecc.) vanno facimente incontro ad aggressioni iterate e gravi di morbigeni esterni. In questi casi è inutile rinforzare la Weiqi (Astragalo, Atractylodes, Liquirizia, Ginseng, ecc.), ma occorre promuovere la conservazione e la secrezione di liquidi. Utile trattare punti che favoriscono la ritenzione di liquidi (7 MP, 10 St e 7 Ki in dispersione) ed impiegare come principio farmacoterapico Sheng Mai San che, oltre a tonificare il Qi con Renshen, astringe i liquidi con la Schizandra e l’Ophipogonis (Prontuario Lao Dan, d. 1998). Tuttavia questo trattamento deve essere fatto in modo preventivo, poiché in fase attiva di malattia più far penetrae in profondità i perversi (G. Giullaume, Mach-Chieu, Rhumatologie et MTC, Ed. Guy Tredaniel, voll II, Paris, 1990).
Ad esempio molte piodermiti secondarie di pazienti anziani (eczema nummulare, eczema microbico vasculo-dipendente) si debbone a debolezza del Qi e carenza di liquidi, con aggessione di Wei e Ying Fen. L’impiego di Sheng Mai San cmbinata con Gui Zhi Tang e di punti come LU2-7, St 10, K1 7 può ridurre l’espressione clinica o prevenire la patologia (Shen De-hui vedi bibliografia, Li Lin: Practical Dermatology in TCM, Ed. Hai Feng Publishing House, Hong Kong, 1995). Sempre rimanendo nel campo delle caratteristiche generali della patologia della 4 zone si deve ricordare che la pentrazione di perversi (vento, freddo, caldo, umidità, secchezza) può avvenire o in modo conforme o per propagazioni non conformi.
Le propagazioni conformi: prevedono il passaggio dalla superficie alla profondità, cioè dalla Weifen alle altre zone più profonde. Ciò significa (Sciarretta op. citata) che la malattia passa successivamente da una zona alla successiva subendo un aggravamento progressivo. |
Le propagazioni non conformi: equivalgano all’interessamento di una zona senza che sia seguita un normale ordine di progressione. Ad es. attacco della Qifen direttamente, saltanto lo strato Wei. Quste si debbono non tanto all’intensità dei morbigeni esterni, uanto alla debolezza dell’energia corretta antipatogena (zhengqi). |
Vediamo ora i sintomi ed il trattamento delle diverse zone seguendo un criterio superficie/profondità
WEIFEN
E’ la zona più superficiale ed il suo interessamento non risulta mai estremamente grave. Si vranno quadr di tipo similinfluenzale con:
febbre leggera
leggera avversione per il vento ed l freddo
cefalea
tosse
sete
faringodinia.
Il polso è galleggiante (fu) la lingua normale con induido colloso.
Tale zona è connessa alla funzione del Polmone per cui, nelle forme pù gravi, dallo strato Wei il perverso va ad interessare il Polmone con
Tosse incessante
Dispnea
Afonia
Faringodinia violenta
Espettorato denso e vischioso e che si stacca con difficoltà
Spesso è difficile una diagnosi differenziale fra attacco della Weifen e sindrom Tai Yang. Di solito nlla sindrom Tai Yang vi saranno dolori muscolari diffusi e cefalea ad irriadiazione nucale più intensa. Comunque in entranbi i casi è consigliata la sudorificazione.
Molte orticarie acute in corso di reazioni febbrili rientrano in questo gruppo (parvovirus, virus coxcakie, Epstein-Barr, ecc.).
La terapia si avvale di:
In farmacoterapia si useranno Gui Zhi Tang se domina il freddo (scarsa febbre, lingua non rossa, scarsa sete, polso non rapido) o, in caso contrario, Yin Qiao San (vedi aggressione Tai Yang). In dietetica cibi Piccanti leggeri freddi o caldi a seconda dei casi. Attenzione ai cibi acidi o troppo dlci che spingono in basso i perversi. Se molto calore dare anche cibi amari-freschi.
QIFEN
La patologia di questa zona si deve o ad aggravamento della sindrome Wei o a fsi di miglioramento dell’agressione dello strato Ying. I segni di calore sono più importanti cono:
febbre elevata di tipo ricorrente
timore per il freddo, sete e traspirazione
urine cariche
respirazione pesante
agitazione, inquetudine e, a volte, delirio
addome gonfio e doloroso
costipazione o incontinenza fecale
bruciore anale.
Il polso è rapido, la lingua mostra patina gialla, collante o è secca.
Da questo strato il calore patogeno può diffondersi ai vari organi e soprattutto colpire i Polmoni, Lo Stomaco, il TR-medio e gli Intestini. Le manifestazioni cutanee sono gonfie e dolorose atipo herpes zooster acuto. Anche l’impetigine contagiosa può rientrare in questo gruppo (con possibili complicazioni glomerulonefritiche).
Secondo la maggior parte degli AA (Van Nghi, Kay An, Faubert, Sciarretta) si hanno cinque diverse posibilità sindromiche:
In farmacoterapia si impiegano formule che chiarificano il calore (qinre fang ji) dallo strato del Qi. I collegi riuniti di Pechino, Nanchino e Shanghai impiegano 20 diverse formule divise in 6 gruppi in base alla gravità ed etiopatogenesi:
| Calore lieve (Wen) |
Calore forte (Re) |
Fuoco (Huo) |
Calore tossico (Du) |
Calore Estivo (Shi Re) |
Calore vuoto (Xu Re) |
Queste formule con principi amari e freddi non possono essere usate per lungo tempo poiché danneggiano il TR-medio, l’appetito e la possibilità di estrarre Guqi. Siccome asciugano bisogna sempre aggiungere tonici dello Yin e dei liquidi. Inoltre possono danneggiare lo Yang della Milza determinando, a lungo andare, lo svluppo di Tan (catarri).
La formula più usata nelle forme da aggressione dello strato Qi è Bai Hu Tang (decotto della tigre bianca), proposta da Zhang Zhong Jing e magnificata da Li Shi Zhen per purificare il calore, eliminare l’agitzione, favorire l’appetito e far produrre liquidi corporei. Nei bambini o nel caso di febbre molto alta si aggiunge panax Ginseng radix e si ottiene la formula Ren Shen Bai Hu Tang (peraltro attiva anche in corso di Encefalite B, come dimostrato da uno studio sul J. Trad. Chin. Med., 1954, 102:30-37). Se si hanno mialgie violente o violenti dolori addominali (accumulo allo stomaco ed agli intestini) si aggiunge il ramulus Cinnamomi (Gui Zhi).
YING FEN
Il calore che persiste a livello dello strato Qi consumerà i liquidi e farà si che il perverso penetri a livello nutritivo. La malattia assume carattere di particolare gravità per il contemporaneo interessamento dello Shen. Pertanto avremo:
perdita di coscienza
delirio
febbre alta che aumenta di notte (puntate fino a 40)
irrequetezza ed insonnia
sete
paralisi spastica dei quattro arti
eruzioni cutanee di tipo purpurico con "nuance" viola
pelle arrossata ed edematosa
polso rapido e sottile
lingua scarlatta.
In realtà sono possibili due diverse sindromi (Faubert e Sciarretta) a seconda che siano consumati i liquidi Jin o Ye.
| Sindrome Jin Ying: febbre che è massima di notte, delirio vrbale, irrequetezza, insonnia. |
Sindrome Ye Ying: febbre elevatissima (40-41), agitazione permanente (Shenzhi), eruzioni maculari, sete, traspirazione abbondante, a volte ematemesi. |
Occorre disperdere il calore, trattare i liquidi e sedare lo Shen. Si impiegano i punti (Colin e Barry) Lu11 (per il calore), Lu 7 (per i liquidi), CV 17 e 21 e GV 26 (per lo Shen).
In farmacoterapia (Ou Ming, Li Fei) si impiega la formula Qing Ying Tang (decotto per purificare lo strato Ying) con un ingredien animale (Xi Jiao, corno di rinocerento) ed altre nove piante che promuovono i fluidi Jin/Ye, purificano il calore del Cuore e calmano il mentale. Le meningiti epidemiche, la febbre emorrargica e petecchiale, le altre ricketsiosi, la herlichiasi, rientrano fra queste affezioni. Le vasculiti purpuriche, la trinsindrome di Gougerot sono trattabli in questo modo (vedi De-Hui in bibliografia).
XUE FEN
Se il calore penetra a livello del sangue si hanno quadri patologici molto gravi con ripercussioni, soprattutto, al Fegato, al Rene ed al Cuore.
Avremo in tutti i casi: perdita di coscienza Delirio spasmi e crampi eruzioni maculari o telengectasiche ematemesi, melena, epistassi spesso ematuria macro o microscopica polso rapido lingua scarlatta |
Tuttavia si possono realizzare 4 differenti sindromi secondo autori italiani (Sciarretta), francesi (Faubert) ed inglesi (Maciocia):
Secondo l’Association Francaise d’Acupuncture occorre rinfrescare (2 LR-11LI) e tonificare (10MP, BL18-20) il sangue ed inoltre ridurre il calore del Cuore, sede dello Shen (BL 15).
Secondo Van Nghi util trattare 7-8 PC e 8 H. Invece D. Colin propone BL42 e 43 e H 3.
In farmacaterapia Xi Jiao Di Huang Tang, con corno di rinoceronte sostituibile con corno di Bufalo a cui aggiungere del tè verde e radice di loto (Ou Jie) per epistassi o altri sanguinamenti. In caso di calore molto intenso (atrafia giallo-acuta del fegato, leucemia acuta, setticemie) utile il prodotto Huang Lian Je Du Tang, che essendo freddo ed amaro può danneggiare lo Yin; ovvero Liang Ge San (decotto per raffreddare il diaframma), cher purifica il calore dagli strati Ying e Xue, libra gli intestini e chiarfica i riscalatori Superiore e Medio. Una patent molto simile è Huang Lian Shang Qing Wan.
Bibliografia |